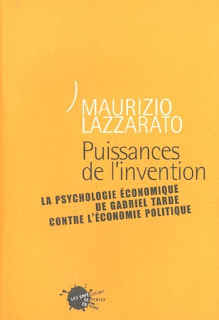Tarde, un teorico dei media
Intervista a Tony D. Sampson, a cura di Jussi Parikka
Traduzione di Alessandro Cattini
Revisione/editing di Obsolete Capitalism
Free download, Click Here
Questa intervista si concentra su una monografia recentemente pubblicata da Tony D. Sampson, Virality: la Teoria del Contagio nell’Era dei Network, descritta da Brian Rotman come “capace di offrire una nuova teoria del virale quale evento sociologico.” In questa conversazione, Parikka e Sampson discutono di Gabriel Tarde e della teoria dell’assemblaggio, e del perché Tarde dovrebbe essere interpretato come un teorico dei media interessato ad una concezione sonnambulistica del sociale. L’interesse di Sampson al noncognitivo – e al capitalismo noncognitivo –suscita risonanze dai recenti dibattiti sulle affezioni, ma con un’attenzione speciale agli sviluppi nel campo dell’interaction design e della ricerca.
Jussi Parikka: Mi piacerebbe cominciare con il chiederti perché ti sei avvicinato al tuo argomento – l’odierna cultura dei network – attraverso Gabriel Tarde, un teorico sociale del XIX secolo? Che cos’è che permette di considerare Tarde come un’adeguata risorsa teoretica per un’analisi della cultura della rete digitale, dove l’azione non risiede soltanto nel contagio umano, ma passa anche per agenti non umani?
Tony Sampson: È stata Tiziana Terranova che, per prima, mi suggerì Tarde, ormai un bel po’ di tempo fa. Stavo cercando di analizzare a fondo queste idee che avevo sui contagi della cultura della rete. Fino a quel momento avevo provato a sviluppare un approccio alle reti simile a quello della teoria dell’assemblaggio, facendo riferimento al materiale fornito dagli studi sulle reti e dalle scienze informatiche. Volevo tenermi ben lontano da un’interpretazione metaforica del contagio digitale, che mi sembrava essere il peggior punto di partenza possibile. Questo approccio ha funzionato bene fino a un certo punto, ma poi la tesi dell’imitazione di Tarde mi ha aperto una vasta gamma di nuove possibilità. È interessante notare che ho potuto volgere di nuovo lo sguardo su Deleuze attraverso il lavoro di Tarde. E’ stato come arrivare nuovamente a lui, intraprendendo un percorso del tutto nuovo. Sebbene Deleuze non abbia scritto un libro su Tarde – e vorrei l’avesse fatto – penso che sia stato influenzato da lui almeno tanto quanto lo fu da Spinoza, Bergson o Nietzsche. È questo il punto che Francois Dosse evidenzia in Intersecting Lives. La cosa più importante è che Tarde mi ha permesso di rileggere la teoria dell’assemblaggio come una teoria sociale o, più precisamente, una teoria della soggettivazione sociale. Mi sento di dire che Tarde è forse il primo teorico dell’assemblaggio, nella misura in cui è davvero preoccupato solamente del desiderio e della relazionalità sociale.
Un’altra cosa importante riguardo al ruolo che Tarde svolge in Virality è che non fa distinzioni tra natura e società o, similmente, tra biologia e cultura. In questo modo mi ha aiutato a demolire l’artificio del contagio metaforico, che fa sembrare che il biologico stia sempre invadendo il sociale, almeno nei punti in cui il linguaggio e la retorica della biologia sembrano imporsi sui fenomeni
sociali. Una volta che l’artificio è stato rimosso, tuttavia, vediamo che è il contrario: ciò che è
biologico è sempre sociale, ed è ciò che è sociale ad essere contagioso. Perciò, quello che in Virality
io chiamo la risurrezione di Tarde, lo colloca come teorico dei media all’interno di una zona indistinta
tra natura e società. E non è stato difficile da fare. Dopotutto, quando scrive di propagazione imitativa
o della suggestionabilità dell’imitazione, Tarde vuole davvero indicare una mediazione monadologica
che non fa distinzioni tra umani e non umani, esattamente come non cerca di separare gli stati inconsci
da quelli consci o le abitudini meccaniche da un senso di volizione. Secondo lui tutti i fenomeni sono
fenomeni sociali, tutte le cose sono società. Quindi come Whitehead, in un certo senso, pone gli
atomi, le cellule e le persone sullo stesso piano: una società di cose. Questo è anche il motivo per cui
ritengo importante evidenziare che ci sono reti nelle masse e masse nelle reti.
Jussi Parikka: “Virality" avanza un’idea intrigante riguardo la teoria dei media del sonnambulo – potresti dirci qualcosa in più riguardo a questo concetto e alla sua relazione con la nonvolizione?
Tony Sampson: Il concetto di “sonnambulo” proviene, ovviamente, ancora una volta da Tarde, e ciò che cerco di fare nel libro è cogliere in che modo questo concetto risuoni con la cultura della rete. Mi sembra che la tendenza al contagio nelle reti sia legata alle implicite funzioni cerebrali che Tarde descrive come associazioni inconsce – attraverso le quali egli afferma che il sociale assembla sé stesso. Questa relazione tra la viralità e l’associazione inconscia potrebbe essere interpretata, se vogliamo, come la diffusione di un capriccioso stato di falsa coscienza, in cui, da un lato, il sociale è infettato dalla suggestionabilità dell’imitazione al livello della funzione cerebrale e, dall’altro lato, ci rendiamo conto che ciascuno è tenuto così impegnato e così distratto da non comprendere realmente che i suoi sentimenti/sensazioni vengono manovrate in direzione di questo o quel fine.
L’idea dei media sonnambuli, o dell’ipnosi dei media, in molti sensi è simile al lavoro di Jonathan Crary sulle tecnologie dell’attenzione. Infatti Crary fornisce un sorprendente riposizionamento della tesi relativa all’economia dell’attenzione. A differenza dell’apporto dato dai guru delle scuole di business, che considerano l’attenzione una preziosa risorsa per cui lottare, egli comprende la natura controllante e disciplinare dell’attenzione. Fuller e Goffeys si sono similmente riferiti a questo come l’economia della disattenzione, che come Crary non fa distinzioni tra attenzione e disattenzione. Non sono poli opposti.
Jussi Parikka: Relativamente a queste idee, insisti con il parlare di capitalismo noncognitivo e delle sue tecniche. Perché questa enfasi, che ti porta in una direzione leggermente diversa rispetto ai tuoi primi anni di studio sulla teoria culturale e politica del capitalismo cognitivo? Che cos’è che rende diverso questo approccio?
Tony Sampson: Dunque, sì, il capitalismo noncognitivo non si discosta troppo dal famigliare flusso di lavoro taylorista e posttaylorista. In termini di lavoro uomocomputer possiamo pensare a questo come a un mutamento di relazioni ergonomiche: il dal migliore adattamento fisico possibile stabilito tra uomo e macchina durante processo di produzione, a un modello cognitivo focalizzato sul lavoro mentale. Vediamo questo mutamento di paradigmi ovunque nella letteratura e nelle pratiche relative alla Human Computer Interaction (HCI), anche se ora qualcosa sta cambiando. L’enfasi è posta sempre di più sul lavoro delle emozioni, degli affetti e delle esperienze, che vengono misurati usando la biometria e le neurotecnologie insieme a strumenti cognitivi più tradizionali che indagano la memoria e l’attenzione. Questo è solo un aspetto della neurocultura in cui ci troviamo oggi, dove non
Jussi Parikka: “Virality" avanza un’idea intrigante riguardo la teoria dei media del sonnambulo – potresti dirci qualcosa in più riguardo a questo concetto e alla sua relazione con la nonvolizione?
Tony Sampson: Il concetto di “sonnambulo” proviene, ovviamente, ancora una volta da Tarde, e ciò che cerco di fare nel libro è cogliere in che modo questo concetto risuoni con la cultura della rete. Mi sembra che la tendenza al contagio nelle reti sia legata alle implicite funzioni cerebrali che Tarde descrive come associazioni inconsce – attraverso le quali egli afferma che il sociale assembla sé stesso. Questa relazione tra la viralità e l’associazione inconscia potrebbe essere interpretata, se vogliamo, come la diffusione di un capriccioso stato di falsa coscienza, in cui, da un lato, il sociale è infettato dalla suggestionabilità dell’imitazione al livello della funzione cerebrale e, dall’altro lato, ci rendiamo conto che ciascuno è tenuto così impegnato e così distratto da non comprendere realmente che i suoi sentimenti/sensazioni vengono manovrate in direzione di questo o quel fine.
L’idea dei media sonnambuli, o dell’ipnosi dei media, in molti sensi è simile al lavoro di Jonathan Crary sulle tecnologie dell’attenzione. Infatti Crary fornisce un sorprendente riposizionamento della tesi relativa all’economia dell’attenzione. A differenza dell’apporto dato dai guru delle scuole di business, che considerano l’attenzione una preziosa risorsa per cui lottare, egli comprende la natura controllante e disciplinare dell’attenzione. Fuller e Goffeys si sono similmente riferiti a questo come l’economia della disattenzione, che come Crary non fa distinzioni tra attenzione e disattenzione. Non sono poli opposti.
Jussi Parikka: Relativamente a queste idee, insisti con il parlare di capitalismo noncognitivo e delle sue tecniche. Perché questa enfasi, che ti porta in una direzione leggermente diversa rispetto ai tuoi primi anni di studio sulla teoria culturale e politica del capitalismo cognitivo? Che cos’è che rende diverso questo approccio?
Tony Sampson: Dunque, sì, il capitalismo noncognitivo non si discosta troppo dal famigliare flusso di lavoro taylorista e posttaylorista. In termini di lavoro uomocomputer possiamo pensare a questo come a un mutamento di relazioni ergonomiche: il dal migliore adattamento fisico possibile stabilito tra uomo e macchina durante processo di produzione, a un modello cognitivo focalizzato sul lavoro mentale. Vediamo questo mutamento di paradigmi ovunque nella letteratura e nelle pratiche relative alla Human Computer Interaction (HCI), anche se ora qualcosa sta cambiando. L’enfasi è posta sempre di più sul lavoro delle emozioni, degli affetti e delle esperienze, che vengono misurati usando la biometria e le neurotecnologie insieme a strumenti cognitivi più tradizionali che indagano la memoria e l’attenzione. Questo è solo un aspetto della neurocultura in cui ci troviamo oggi, dove non
è la persona, ma il neurone o forse persino la neurotrasmissione stessa che viene messa all’opera in
ogni modo per produrre un nuovo tipo di soggettività molecolare.
Fino alla seconda fase di scrittura del libro non avevo cominciato a leggere il lavoro dello psicologo sociale Robert Zajonc, sulle preferenze che non richiedono inferenze; vale a dire la sua idea che le sensazioni potrebbero avere pensieri propri. Infatti, se i commercianti, i politici e i designer possono farci sentire in un certo modo, allora possono anche avere influenza sul nostro modo di pensare. Questo rispecchia la tendenza del design commerciale oggi, a cogliere l’importanza della relazione tra emozioni e conoscenza. Ma Zajonc va persino oltre dicendo che i sistemi affettivi sono sia indipendenti da, e forse persino più forti dei sistemi cognitivi. Potenzialmente i gli uomini del marketing, i politici e i designer non hanno nemmeno la seccatura di doversi appellare al pensiero. Penso che questa sia la traiettoria seguita dal capitalismo noncognitivo.
In aggiunta al lavoro delle neurotrasmissioni c’è anche questo ben pubblicizzato mutamento nella tecnologia dei media verso il cosiddetto ubicomp (computazione ubiqua). Anche questo è importante. Qui vediamo interazioni sconosciute al soggetto (nontask interactions) verificarsi anche al di sotto del livello di attenzione. Il calcolo pervasivo funziona anche mediante la produzione di interazioni che lavorano sull’utente, semplicemente grazie al fatto che l’utente viene in contatto con una zona “calda” o diventa parte di una rete fra dispositivi, scatenando così un evento di cui non avrà mai bisogno di essere a conoscenza.
Jussi Parikka: Le tue idee sembrano essere strettamente in relazione con “Evil Media”, un recente libro di MatthewFuller e Andrew Goffey. C’è un più vasto interesse per gli aspetti non comunicativi e non rappresentazionali della cultura dei media?
Tony Sampson: Assolutamente sì, il che costituisce anche il motivo per cui sono stato così felice di parlare di Virality per la prima volta insieme a Matt e Andy presso il Goldsmiths. Penso che ci sia una bella sincronia tra il mio libro e ciò che loro chiamano il grigiore non intrusivo di alcune pratiche mediatiche. Non si tratta soltanto dell’uso strategico dei media per scopi specifici, o della rivelazione di una qualche ideologia incorporata o nascosta; al contrario, [la sincronia riscontrata nelle due opere] indica le conseguenze derivanti dalla non intenzionalità e dalla riappropriazione di incidenti devianti. Ho scritto dello stratagemma immunologico come un certo tipo di allarmismo ingannevole originato da incidenti della computer science negli anni settanta e ottanta del Novecento. Questo è il modo in cui vedo la cultura virale. Non è come piacerebbe al marketing virale, cioè una procedura che conduce passo dopo passo ad un costo di marketing pari a zero. Al contrario vediamo che un imprenditore digitale deve mettere in moto la viralità ottimizzando marchi così che essi siano più efficaci dei loro rivali e il loro potenziale si diffonda il più possibile. Nel marketing in rete nulla è dato per certo. Tutto ciò che puoi realmente fare è ammazzare il tempo mentre aspetti di gestire il prossimo incidente casuale.
Un’altra connessione che ho recentemente instaurato con Evil Media è con il gruppo di artisti YoHa. Mi hanno chiesto un contributo per il loro progetto Evil Media, Curiosity Cabinet che sarà esposto a Berlino nell’anno nuovo. Ho optato per Modafinil. Questo neurofarmaco viene usato principalmente per trattare i disturbi del sonno, alcuni dei quali sono direttamente connessi al malfunzionamento dei processi di lavoro, come i disordini derivanti da un cambio di lavoro. Questo sarebbe già abbastanza
Fino alla seconda fase di scrittura del libro non avevo cominciato a leggere il lavoro dello psicologo sociale Robert Zajonc, sulle preferenze che non richiedono inferenze; vale a dire la sua idea che le sensazioni potrebbero avere pensieri propri. Infatti, se i commercianti, i politici e i designer possono farci sentire in un certo modo, allora possono anche avere influenza sul nostro modo di pensare. Questo rispecchia la tendenza del design commerciale oggi, a cogliere l’importanza della relazione tra emozioni e conoscenza. Ma Zajonc va persino oltre dicendo che i sistemi affettivi sono sia indipendenti da, e forse persino più forti dei sistemi cognitivi. Potenzialmente i gli uomini del marketing, i politici e i designer non hanno nemmeno la seccatura di doversi appellare al pensiero. Penso che questa sia la traiettoria seguita dal capitalismo noncognitivo.
In aggiunta al lavoro delle neurotrasmissioni c’è anche questo ben pubblicizzato mutamento nella tecnologia dei media verso il cosiddetto ubicomp (computazione ubiqua). Anche questo è importante. Qui vediamo interazioni sconosciute al soggetto (nontask interactions) verificarsi anche al di sotto del livello di attenzione. Il calcolo pervasivo funziona anche mediante la produzione di interazioni che lavorano sull’utente, semplicemente grazie al fatto che l’utente viene in contatto con una zona “calda” o diventa parte di una rete fra dispositivi, scatenando così un evento di cui non avrà mai bisogno di essere a conoscenza.
Jussi Parikka: Le tue idee sembrano essere strettamente in relazione con “Evil Media”, un recente libro di MatthewFuller e Andrew Goffey. C’è un più vasto interesse per gli aspetti non comunicativi e non rappresentazionali della cultura dei media?
Tony Sampson: Assolutamente sì, il che costituisce anche il motivo per cui sono stato così felice di parlare di Virality per la prima volta insieme a Matt e Andy presso il Goldsmiths. Penso che ci sia una bella sincronia tra il mio libro e ciò che loro chiamano il grigiore non intrusivo di alcune pratiche mediatiche. Non si tratta soltanto dell’uso strategico dei media per scopi specifici, o della rivelazione di una qualche ideologia incorporata o nascosta; al contrario, [la sincronia riscontrata nelle due opere] indica le conseguenze derivanti dalla non intenzionalità e dalla riappropriazione di incidenti devianti. Ho scritto dello stratagemma immunologico come un certo tipo di allarmismo ingannevole originato da incidenti della computer science negli anni settanta e ottanta del Novecento. Questo è il modo in cui vedo la cultura virale. Non è come piacerebbe al marketing virale, cioè una procedura che conduce passo dopo passo ad un costo di marketing pari a zero. Al contrario vediamo che un imprenditore digitale deve mettere in moto la viralità ottimizzando marchi così che essi siano più efficaci dei loro rivali e il loro potenziale si diffonda il più possibile. Nel marketing in rete nulla è dato per certo. Tutto ciò che puoi realmente fare è ammazzare il tempo mentre aspetti di gestire il prossimo incidente casuale.
Un’altra connessione che ho recentemente instaurato con Evil Media è con il gruppo di artisti YoHa. Mi hanno chiesto un contributo per il loro progetto Evil Media, Curiosity Cabinet che sarà esposto a Berlino nell’anno nuovo. Ho optato per Modafinil. Questo neurofarmaco viene usato principalmente per trattare i disturbi del sonno, alcuni dei quali sono direttamente connessi al malfunzionamento dei processi di lavoro, come i disordini derivanti da un cambio di lavoro. Questo sarebbe già abbastanza
orribile, ma il grigiore di Modafinil diviene chiaro nell’abuso che ne fanno gli studenti e i soldati che
hanno bisogno di rimanere attenti durante gli esami universitari o sul campo di battaglia.
Jussi Parikka: Nonostante le differenze da Evil Media, sembra che anche tu parli d’amore nel tuo libro – puoi approfondire questo aspetto, in relazione alle affetti?
Tony Sampson: Dunque, c’è questa cosa davvero intrigante e machiavellica in Evil Media, giusto? È che la paura è preferibile all’amore. Il mio lavoro semplicemente gira quell’idea su sé stessa. Tarde scrive riguardo all’amore in diverse occasioni, nel suo romanzo Underground Man e nella parte extralogica di The Laws of Imitation. Egli pensa che l’amore sia, sebbene spesso transitorio, molto più contagioso della paura. Egli lo considera come una relazione di potere asimmetrica nella quale è principalmente chi ama a copiare il suo amato. Mi sono ispirato a questo e a un paio di altri autori. Teresa Brennan, per esempio, scrive che l’amore, a differenza della paura, non ha bisogno di un medium a cui appigliarsi. L’amore per Brennan è contemporaneamente affezione e medium, il che in qualche modo incrementa il suo contagio affettivo. L’amore di Michael Hardt come concetto politico è ugualmente interessante, secondo me. La sua concezione che l’amore per la famiglia, per la razza, per dio e per la nazione tenda a unificare i popoli in modi che sono “dannosi” diventa significativa, penso, per comprendere l’amore come un Trojan molto più efficace e sinistro della paura. Infatti, solo perché un’esperienza ti fa sentire bene non significa che sarà buona per te. Guardo all’Obama Love sotto questa luce – come un tipo di pratica mediatica grigia e virale dell’amore. Al di là degli ovvi modi di servirsi dell’amore nella sua campagna, come i siti, le magliette e le spille di I Love Obama, ci sono anche quelle immagini aptiche del presidente con la sua famiglia alla vigilia della suo primo trionfo elettorale. Sentiamo come questo ragazzo molto cool voglia instaurare una nuova collaborazione con il Medio Oriente e chiudere Guantanamo, ma tutto quello che otteniamo sono le impennate nei numeri delle truppe, il suo iniziale supporto al regime di Mubarack, e l’inarrestabile ascesa dei droni. I suoi sostenitori affermano che vuole vedere Guantanamo chiusa, quindi deve essere o disonesto o del tutto incapace. Questo è il grigiore dell’amore verso Obama.
Jussi Parikka: Una delle parti più intriganti del libro è quella in cui analizzi le tecnologie concrete che stanno emergendo, come quelle tecniche di progettazione di interfacce di design che rientrano nella sfera dell’involontario. Si tratta di un’altra specie di livello di modulazione delle affetti, per esempio per ciò che riguarda il design di interfacce basate sugli affetti? E ciò come sta in relazione con il recente più ampio dibattito riguardante gli affetti nelle “teoria della cultura”?
Tony Sampson: Ritengo che la teoria del sonnambulismo dei media sia un utile strumento per comprendere il cosiddetto terzo paradigma di HCI, l’interazione uomocomputer. È questa la mossa che permette di sfruttare i già menzionati emozioni e affetti, il contesto sociale e l’elaborazione dell’esperienza. Infatti, in quanto parte di questo movimento, i consulenti di design dell’esperienza e i neuromarketer stanno velocemente diventando il prossimo grande fenomeno nel business della persuasione. I loro più grandi clienti a quanto pare sono le banche e altri istituti finanziari. Non sorprende che queste imprese abbiano un problema d’immagine al momento. Quindi sono desiderose di guadagnare la possibilità di mettere in contatto l’utente finale con il loro brand attraverso il livello viscerale della elaborazione dell’esperienza, facendo leva direttamente sugli appetiti. Questo è ciò che il design emotivo promette di fare.
Jussi Parikka: Nonostante le differenze da Evil Media, sembra che anche tu parli d’amore nel tuo libro – puoi approfondire questo aspetto, in relazione alle affetti?
Tony Sampson: Dunque, c’è questa cosa davvero intrigante e machiavellica in Evil Media, giusto? È che la paura è preferibile all’amore. Il mio lavoro semplicemente gira quell’idea su sé stessa. Tarde scrive riguardo all’amore in diverse occasioni, nel suo romanzo Underground Man e nella parte extralogica di The Laws of Imitation. Egli pensa che l’amore sia, sebbene spesso transitorio, molto più contagioso della paura. Egli lo considera come una relazione di potere asimmetrica nella quale è principalmente chi ama a copiare il suo amato. Mi sono ispirato a questo e a un paio di altri autori. Teresa Brennan, per esempio, scrive che l’amore, a differenza della paura, non ha bisogno di un medium a cui appigliarsi. L’amore per Brennan è contemporaneamente affezione e medium, il che in qualche modo incrementa il suo contagio affettivo. L’amore di Michael Hardt come concetto politico è ugualmente interessante, secondo me. La sua concezione che l’amore per la famiglia, per la razza, per dio e per la nazione tenda a unificare i popoli in modi che sono “dannosi” diventa significativa, penso, per comprendere l’amore come un Trojan molto più efficace e sinistro della paura. Infatti, solo perché un’esperienza ti fa sentire bene non significa che sarà buona per te. Guardo all’Obama Love sotto questa luce – come un tipo di pratica mediatica grigia e virale dell’amore. Al di là degli ovvi modi di servirsi dell’amore nella sua campagna, come i siti, le magliette e le spille di I Love Obama, ci sono anche quelle immagini aptiche del presidente con la sua famiglia alla vigilia della suo primo trionfo elettorale. Sentiamo come questo ragazzo molto cool voglia instaurare una nuova collaborazione con il Medio Oriente e chiudere Guantanamo, ma tutto quello che otteniamo sono le impennate nei numeri delle truppe, il suo iniziale supporto al regime di Mubarack, e l’inarrestabile ascesa dei droni. I suoi sostenitori affermano che vuole vedere Guantanamo chiusa, quindi deve essere o disonesto o del tutto incapace. Questo è il grigiore dell’amore verso Obama.
Jussi Parikka: Una delle parti più intriganti del libro è quella in cui analizzi le tecnologie concrete che stanno emergendo, come quelle tecniche di progettazione di interfacce di design che rientrano nella sfera dell’involontario. Si tratta di un’altra specie di livello di modulazione delle affetti, per esempio per ciò che riguarda il design di interfacce basate sugli affetti? E ciò come sta in relazione con il recente più ampio dibattito riguardante gli affetti nelle “teoria della cultura”?
Tony Sampson: Ritengo che la teoria del sonnambulismo dei media sia un utile strumento per comprendere il cosiddetto terzo paradigma di HCI, l’interazione uomocomputer. È questa la mossa che permette di sfruttare i già menzionati emozioni e affetti, il contesto sociale e l’elaborazione dell’esperienza. Infatti, in quanto parte di questo movimento, i consulenti di design dell’esperienza e i neuromarketer stanno velocemente diventando il prossimo grande fenomeno nel business della persuasione. I loro più grandi clienti a quanto pare sono le banche e altri istituti finanziari. Non sorprende che queste imprese abbiano un problema d’immagine al momento. Quindi sono desiderose di guadagnare la possibilità di mettere in contatto l’utente finale con il loro brand attraverso il livello viscerale della elaborazione dell’esperienza, facendo leva direttamente sugli appetiti. Questo è ciò che il design emotivo promette di fare.
Ecco che cosa sta accadendo: ho partecipato a un certo numero di eventi relativi all’industria del
design recentemente, dove tecniche biometriche sono messe in pratica da designer di app, giochi
pubblicitari, eCommerce. Si stanno entusiasticamente collegando gli affetti generati dall’utente a
strumenti di rilevazioni di galvanizzazione della pelle ed elettroencefalogramma,assieme a software
di riconoscimento facciale e posturale con tecnologie del tracciamento oculare per esplorare come
certi stati emotivi di valenza affettiva rilevabili possano corrispondere a cose come l’identificazione di
un brand e l’intenzione all’acquisto. C’è qui il desiderio di comprendere che cosa accada all’utente a
livello non conscio della elaborazione dell’esperienza, cosicché i brand possano essere innestati e gli
utenti manovrati e condotti verso certe finestre di opportunità.
Di nuovo, queste pratiche concrete sono immerse nel grigiore. Queste tecnologie e questi metodi erano indirizzati, in origine, al trattamento neurologico di condizioni come i deficit di attenzione e la demenza. Ma, ora, non vi sono secondi fini nascosti nella loro riproposizione. Non vi è nessuno sforzo di mascherare l’invadenza di queste tecniche di marketing. La pratica della persuasione, che era divenuta una specie di taboo nelle vecchie arene mediatiche, è ritornata, sembrerebbe, per vendicarsi.
Di nuovo, queste pratiche concrete sono immerse nel grigiore. Queste tecnologie e questi metodi erano indirizzati, in origine, al trattamento neurologico di condizioni come i deficit di attenzione e la demenza. Ma, ora, non vi sono secondi fini nascosti nella loro riproposizione. Non vi è nessuno sforzo di mascherare l’invadenza di queste tecniche di marketing. La pratica della persuasione, che era divenuta una specie di taboo nelle vecchie arene mediatiche, è ritornata, sembrerebbe, per vendicarsi.
L’intervista è stata pubblicata online, in lingua inglese, il 25 gennaio 2013 sulla rivista Theory,
Culture and Society, che qui pubblicamente ringraziamo per il permesso alla traduzione e
pubblicazione. L’originale dell’intervista è rintracciabile al seguente indirizzo:
http://www.theoryculturesociety.org/tardeasmediatheoristaninterviewwithtonydsampsonbyju
ssiparikka/
Biografie:
Biografie:
Tony D. Sampson
Inglese, insegna Digital Culture and Communication presso la School of Arts and Digital Industries dell'University of East London (UEL, UK). Ama lavorare ad eventi artistici sperimentali che coinvolgono musica, video e filosofia. La sua ricerca analizza il ‘lato oscuro’ che si sta realizzando tra sociologia, marketing, cultura digitale e neuroscienze, in particolare la deriva contagiosa e virale che si dipana nelle microrelazioni di massa circolanti nei New Media. É coeditore (con Jussi Parikka) del libro Spam Book: On Viruses, Porn, and Other Anomalies From the Dark Side of Digital Culture (Cresskill, NJ: Hampton Press, 2009). Il suo ultimo libro Virality: Contagion Theory in the Age of Networks incrocia la microsociologia di Gabriel Tarde con la filosofia dell'evento di Gilles Deleuze; è stato pubblicato nel Giugno del 2012 dalla University of Minnesota Press. Ha un blog personale, Virality. Il prossimo libro uscirà nella primavera del 2017 con il titolo The Assemblage Brain: Sense Making in Times of Neurocapitalism per la Minnesota University Press.
Jussi Parikka
Finlandese, insegna Technological Culture & Aesthetics at University of Southampton (UK) ed é docente in Digital Culture Theory alla University of Turku in Finlandia. Parikka è un noto teorico dei New Media a livello internazionale. Tra le pubblicazioni, da segnalare: What is Media Archaeology? (Polity: Cambridge, 2012); Insect Media: An Archaeology of Animals and Technology (University of Minnesota Press: Minneapolis, 2010) Posthumanitiesseries; Digital Contagions. A Media Archaeology of Computer Viruses (Peter Lang: New York, 2007); e, con Erkki Huhtamo, Media Archæology: Approaches, Applications, and Implications (University of California Press, Los Angeles, 2011). É coeditore (Tony D. Sampson) del libro Spam Book: On Viruses, Porn, and Other Anomalies From the Dark Side of Digital Culture (Cresskill, NJ: Hampton Press, 2009). Le più recenti uscite sono: il testo The Anthrobscene (University of Minnesota Press, 2014) e l’opera A Geology of Media (University of Minnesota Press, 2015). Sta attualmente lavorando alla pubblicazione (2016) per la seconda edizione di Digital Contagions. Ha un blog personale, Machinology.
Inglese, insegna Digital Culture and Communication presso la School of Arts and Digital Industries dell'University of East London (UEL, UK). Ama lavorare ad eventi artistici sperimentali che coinvolgono musica, video e filosofia. La sua ricerca analizza il ‘lato oscuro’ che si sta realizzando tra sociologia, marketing, cultura digitale e neuroscienze, in particolare la deriva contagiosa e virale che si dipana nelle microrelazioni di massa circolanti nei New Media. É coeditore (con Jussi Parikka) del libro Spam Book: On Viruses, Porn, and Other Anomalies From the Dark Side of Digital Culture (Cresskill, NJ: Hampton Press, 2009). Il suo ultimo libro Virality: Contagion Theory in the Age of Networks incrocia la microsociologia di Gabriel Tarde con la filosofia dell'evento di Gilles Deleuze; è stato pubblicato nel Giugno del 2012 dalla University of Minnesota Press. Ha un blog personale, Virality. Il prossimo libro uscirà nella primavera del 2017 con il titolo The Assemblage Brain: Sense Making in Times of Neurocapitalism per la Minnesota University Press.
Jussi Parikka
Finlandese, insegna Technological Culture & Aesthetics at University of Southampton (UK) ed é docente in Digital Culture Theory alla University of Turku in Finlandia. Parikka è un noto teorico dei New Media a livello internazionale. Tra le pubblicazioni, da segnalare: What is Media Archaeology? (Polity: Cambridge, 2012); Insect Media: An Archaeology of Animals and Technology (University of Minnesota Press: Minneapolis, 2010) Posthumanitiesseries; Digital Contagions. A Media Archaeology of Computer Viruses (Peter Lang: New York, 2007); e, con Erkki Huhtamo, Media Archæology: Approaches, Applications, and Implications (University of California Press, Los Angeles, 2011). É coeditore (Tony D. Sampson) del libro Spam Book: On Viruses, Porn, and Other Anomalies From the Dark Side of Digital Culture (Cresskill, NJ: Hampton Press, 2009). Le più recenti uscite sono: il testo The Anthrobscene (University of Minnesota Press, 2014) e l’opera A Geology of Media (University of Minnesota Press, 2015). Sta attualmente lavorando alla pubblicazione (2016) per la seconda edizione di Digital Contagions. Ha un blog personale, Machinology.