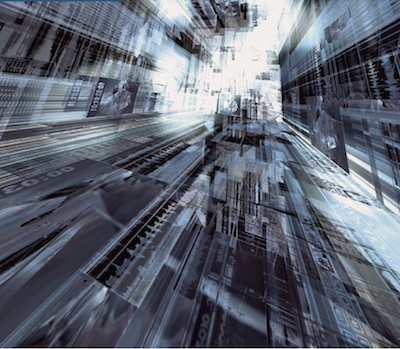I forti dell'avvenire: il frammento accelerazionista di Friedrich Nietzsche nell'Anti-Edipo di Deleuze e Guattari - WM 898 e/o FP VOL.VIII TOMO II (105) 9 [153] Autunno 1887
Com'è noto, il riferimento a Nietzsche nel celebre passo 'accelerazionista' di Deleuze e Guattari presente nell'Anti-Edipo (1972) è decisivo nella chiosa finale del paragrafo 'La macchina capitalistica civilizzata' (III Cap. - 9 Paragrafo - pg. 251 - 272). Fino ad oggi, i vari commentatori che si sono succeduti nel tempo sul passo in questione, hanno in parte tralasciato e oscurato il preciso riferimento al 'Große Prozeß' di Friedrich Nietzsche, altri, invece, hanno accennato alla provenienza dell'oscuro riferimento di 'accelerare il processo', da parte di Deleuze e Guattari, citando esplicitamente il libro di Nietzsche 'La volontà di potenza', non riferendosi però mai ad un preciso frammento, al contesto in cui è inserito e quali tematiche produttive sviluppa. Le citazioni del passo originario di Nietzsche provengono sempre dalla letteratura 'secondaria' e non vengono mai citate le fonti originarie dell'opera nietzschiana (tranne una fuggevole nota in Wikipedia, in lingua inglese, nel lemma 'accelerationism', proveniente però dalla letteratura secondaria).
A nostro avviso, la chiosa finale di 'La macchina capitalistica civilizzata', essendo controversa, non può essere compresa nel suo senso più profondo se non viene esplicitato il riferimento al processo accelerativo di Nietzsche.
Il celebre passo di Deleuze e Guattari, vero e proprio punto cruciale per i commentatori, soprattutto di area 'accelerazionista', è il seguente:
"Ma quale via rivoluzionaria, ce n'è forse una? Ritirarsi dal mercato mondiale, come consiglia Samir Amin ai paesi del Terzo Mondo, in un curioso rinnovamento della «soluzione economica» fascista? Oppure, andare in senso contrario? Cioè andare ancor più lontano nel movimento del mercato, della decodificazione e della deterritorializzazione? Forse, infatti, i flussi non sono ancora abbastanza deterritorializzati, abbastanza decodificati, dal punto di vista di una teoria e di una pratica dei flussi ad alto tenore schizofrenico. Non ritirarsi dal processo, ma andare più lontano, «accelerare il processo», come diceva Nietzsche: in verità, su questo capitolo, non abbiamo ancora visto nulla."
Le nostre ricerche hanno portato ad individuare con precisione il frammento di Nietzsche citato da Deleuze e Guattari nel passo sopra riportato. Si tratta di un frammento presente in due edizioni diverse delle opere postume di Friedrich Nietzsche. Il frammento si intitola 'I forti dell'avvenire'. E' stato composto nell'autunno del 1887. Nell'edizione del 1906 di 'La volontà di potenza' curata da Gast e dalla sorella di Nietzsche gli è stato attribuito arbitrariamente il numero 898 (tale numero si riferisce esclusivamente ad una numerazione progressiva interna al solo Volontà di potenza). Questa edizione del 1906 prevedeva 1.067 frammenti elencati senza un disegno globale coerente e critico. Questa è una storia ben nota, almeno dagli anni Sessanta del secolo scorso, che ha però causato numerosi fraintendimenti. Lo stesso frammento, con lo stesso titolo 'I forti dell'avvenire' è presente nell'edizione delle Opere complete di Friedrich Nietzsche, a cura di Colli e Montinari. Il frammento è inserito nel Volume VIII, tomo II, intitolato 'Frammenti postumi 1887-1888', ove sono presentati cronologicamente i 372 frammenti che, per i curatori, erano compresi nell'edizione abortita da Nietzsche stesso e da lui intitolata 'La volontà di potenza'.
Il frammento è numerato come (105) 9 [153].
Nel testo originale del frammento, Die Starken der Zukunft, il verbo utilizzato da Nietzsche, tratto dal mondo della fisica, è «beschleunigen» il cui significato è letteralmente «rendere accelerato qualcosa procurandone un corso più veloce». Nella traduzione in inglese del 1967 di Kaufmann, la più classica nel mondo anglosassone, si è scelto di tradurre il verbo «beschleunigen» con il verbo inglese «hasten» anziché «accelerate», sebbene anche in questo idioma il termine «accelerate» si riferisca all'aumento intrinseco di velocità di un processo, mentre il significato di «hasten» prende in considerazione la necessità, non solo fisica, di aumentare la velocità. Anche nella lingua italiana è stato scelto il verbo «affrettare», in tutte e due le traduzioni presentate, anziché «accelerare». A maggior ragione, notiamo la differenza tra i due vocaboli: laddove «accelerare» denota il velocizzare intrinseco e fisico di un evento o di un fatto, «affrettare» indica la prescrizione esterna di un aumento di velocità.
In realtà, l'unico commentatore che ci può essere utile nella comprensione sia del passo di Nietzsche sia della citazione nietzscheana di Deleuze e Guattari è Pierre Klossowski (1905-2001), nella sua opera 'Nietzsche e il circolo vizioso' (Adelphi, 1981), libro assai amato da Foucault e Deleuze, al quale in esergo è dedicato (l'opera originale in francese è del 1969). L'utilità-fertilità di Klossowski è duplice, sia per la natura esegetica del testo 'Nietzsche e il circolo vizioso', sia per la fruttificazione operata dalle traduzioni klossowskiane del testo nietzscheano. Quest'ultimo aspetto è estremamente importante ai nostri fini. Cerchiamo di chiarirlo: non solo Klossowski è stato un grande traduttore nell'ambito della cultura francese, un 'classico' nell'editoria francofona del '900, in quanto ha tradotto, dal tedesco, opere di Walter Benjamin, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger (in particolare, nel 1971, il suo 'Nietzsche'). Klossowski ha il merito di esser stato il miglior interprete di Nietzsche in Francia, già con la sua magistrale resa di 'La gaia scienza' nel 1954; ma, in particolare, ha tradotto i 'Fragments posthumes - Autumn 1887-mars 1888' usciti per Gallimard nel 1976. Il frammento 'Les forts de l'avenir' non ha dovuto attendere il 1976 per essere pubblicato nella traduzione klossowskiana in quanto inserito nell'edizione originale di 'Nietzsche et le cercle vicieux' del 1969. Ed è qui che finalmente troviamo il verbo «beschleunigen» tradotto in «accélérer»; dunque, all'origine dell'utilizzo del verbo 'accelerare' o dell'espressione 'accelerare il processo' di cui ci si avvale nell'esegesi del frammento nietzscheano, c'è il lavorio interpretativo di Klossowski. Deleuze, e Guattari, quando nel finale di 'La macchina capitalistica civilizzata' pongono le fatidiche domande su quale via rivoluzionaria intraprendere, richiamate all'inizio del nostro scritto - e queste domande sono alla base della strategia di fondo dell'accelerazionismo contemporaneo - si rifanno dunque al lavoro teorico e traduttivo di Pierre Klossowski.
Proponiamo ora la traduzione integrale di Klossowski del frammento (105) 9 [153] 'Les forts de l'avenir':
Per quanto riguarda l'aspetto esegetico
Klossowski prende in esame nelle pagine immediatamente successive (pg. 241 e seguenti, edizione originale francese) l'intero frammento di Nietzsche, I forti dell'avvenire', traendone le debite conseguenze; cioè che il pensiero nietzscheano del 1887 da 'inattuale' è divenuto di un'attualità sconcertante, cent'anni dopo, e che in ultima istanza 'il meccanismo economico di sfruttamento si è decomposto da struttura istituzionale a un insieme di mezzi'. Ciò comporta due precisi risultati: da una parte la società non riesce più a modellare i propri membri come «strumenti» dei propri fini, divenendo essa stessa «strumento» di un meccanismo più grande; dall'altra parte c'è un 'surplus' di forze che, eliminate dal meccanismo, sono disponibili per la formazione di un 'nuovo uomo', il forte dell'avvenire. Per ottenere questo nuovo tipo d'uomo, non bisogna allora combattere questo 'große prozeß' irreversibile, ma semplicemente bisogna favorire la sua accelerazione, o non resistere alla sua accelerazione espansiva inarrestabile che appare essere, ma non è, contraria al suo obiettivo: il livellamento - cioè l'omogeneizzazione nella sua veste perpetrata dalla democratizzazione in essere delle società industriali - è precisamente la 'riduzione' dell'uomo, il suo «rimpicciolimento». E' contro, o a favore, di questa 'legge inesorabile' che agiranno nel futuro i «forti» e i «livellati», in parti curiosamente e paradossalmente rovesciate. Così come, è contro o a favore dell'«inesorabile legge» della caduta tendenziale della legge di profitto, che si combattono i capitalisti e gli operai, in una controversa metastabilizzazione del futuro del profitto, che è l'altro grande tema del paragrafo sopracitato di Deleuze e Guattari.
Il testo completo, grazie agli editori Adelphi e Bompiani, è presentato nelle tre traduzioni storiche pubblicate nel 1927 (Treves), 1971 (Giametta), e 1981 (Turolla).
Buona lettura.
I forti dell'avvenire (Autunno 1887)
Ciò che in parte il bisogno, in parte il caso hanno qua e là raggiunto, ossia le condizioni per la produzione di una specie più forte: tutto questo possiamo ora comprenderlo e volerlo consapevolmente; possiamo creare le condizioni in cui un tale potenziamento sia possibile.
L'«educazione» ha avuto finora di mira l'utile della società, non già il maggior utile possibile dell'avvenire, bensì l'utile della società in quel momento esistente. Si volevano «strumenti» per essa. Posto che ricchezza di energia fosse maggiore, si potrebbe pensare a una DETRAZIONE DI FORZE il cui fine non fosse l'utile della società, ma un utile futuro -
Un tal compito sarebbe tanto più da proporre, quanto più si comprendesse in che misura la forma presente della società è in forte trasformazione, al punto di non poter più esistere, un giorno futuro, per se stessa, ma solo più come mezzo nelle mani di una razza più forte. Il crescente rimpicciolimento dell'uomo è appunto la forza motrice per pensare all'allevamento di una razza più forte, che troverebbe il suo sovrappiù proprio nella sfera in cui la specie rimpicciolita si indebolirebbe sempre di più (volontà, responsabilità, sicurezza di sé, capacità di porsi degli scopi).
I mezzi sarebbero quelli che la storia insegna: l'isolamento attraverso interessi di conservazione opposti a quelli che sono oggi correnti; l'esercitarsi in giudizi di valore opposti; la distanza come pathos; la coscienza libera in ciò che oggi è più sottovalutato e vietato.
Il livellamento dell'uomo europeo è il grande processo che non si deve ostacolare: bisognerebbe affrettarlo ancora di più.
È così data la necessità dello spalancarsi di un abisso, della distanza, della gerarchia: non la necessità di rallentare quel processo.
Questa specie livellata, appena è raggiunta, abbisogna di una giustificazione, che consiste nel servire un tipo superiore, sovrano, che sta sopra di essa e che solo poggiando su di essa può innalzarsi al suo compito.
Non solo una razza di signori, il cui compito si esaurisca nel governare; ma una razza con una propria sfera di vita, con un sovrappiù di forza per la bellezza, il valore, la cultura, il comportamento, sino a ciò che è più spirituale; una razza affermatrice, che possa concedersi ogni grande lusso..., abbastanza forte per non aver bisogno della tirannia dell'imperativo della virtù, abbastanza ricca per non aver bisogno della parsimonia e della pedanteria, al di là di bene e male; una serra per piante speciali e scelte.
Friedrich Nietzsche - Frammenti postumi 1887-1888
Volume VIII, tomo II delle « Opere di Friedrich Nietzsche »
Edizione italiana condotta sul testo critico stabilito da Giorgio Colli e Mazzino Montinari.
Titolo del frammento :
I forti dell'avvenire ( 105 ) 9 [ 153 ]
(Adelphi, 1971) -
Traduzione: Sossio Giametta
*** Ringraziamo il filosofo Luigi Rustichelli per l'aiuto prezioso nella ricerca del frammento accelerazionista di Friedrich Nietzsche
§ § § § § § § § §
I forti dell'avvenire
Ciò che in parte la necessità, in parte il caso hanno ottenuto sporadicamente, ciò le condizioni per la produzione di una specie più forte, possiamo ora comprenderlo e volerlo scientemente: noi possiamo creare le condizioni in cui una simile elevazione sia possibile.
Finora, l'«educazione» ha mirato all'utile della società: non ciò che è più utile per l'avvenire, ma l'utile della società esistente. Si volevano «strumenti» per questa società. Posto che fossimo più ricchi di energie, si potrebbe pensare a trattenere una quota non destinata a giovare alla società, ma per un'utilità futura.
Tanto più dovremmo porci un simile compito, quanto più comprendessimo come la forma presente della società si trovi in una fase di forte trasformazione: cioè sulla via che potrà un giorno portarla a non esistere più per se stessa, ma soltanto come un mezzo nelle mani di una razza più forte.
Il crescente rimpicciolimento dell'uomo è precisamente la forza che spinge a pensare all'allevamento di una razza più forte, una razza i cui tratti eccessivi sarebbero proprio quelli in cui la specie rimpicciolita diventerebbe sempre più debole (cioè volontà, responsabilità, sicurezza, facoltà di porsi degli scopi).
I mezzi sarebbero quelli che la storia insegna: l'isolamento mediante interessi di conservazione opposti a quelli che sono oggi gli interessi medi; l'addestramento a produrre valutazioni opposte; la distanza considerata come pathos; la libera coscienza in ciò che oggi è disprezzato e vietato.
Il livellamento dell'uomo europeo è il grande processo che non si deve ostacolare: anzi, lo si dovrebbe affrettare.
Da ciò risulta la necessità di aprire un abisso, di creare distanze e una gerarchia: non la necessità di rallentare quel processo.
Nel momento in cui la si sia ottenuta, questa specie livellata ha bisogno di una giustificazione: e questa si trova nel servire una specie più alta e sovrana, che si basa su quella e solo basandosi su quella può elevarsi al proprio compito.
Non si avrà soltanto una razza di signori il cui compito si esaurisca nel governare, ma una razza con una propria sfera vitale, energie in eccesso per la bellezza, il coraggio, la cultura, le maniere, giungendo a ciò che c'è di più spirituale: una razza affermatrice che si può concedere ogni grande lusso - abbastanza forte per non avere bisogno della tirannia dell'imperativo della virtù, abbastanza ricca per non avere bisogno della parsimonia e della pedanteria, di là dal bene e dal male; una serra per piante rare ed elette.
Friedrich Nietzsche - La volontà di potenza
Saggio di una trasvalutazione di tutti i valori
Frammenti postumi ordinati da Peter Gast e Elisabeth Förster-Nietzsche. Nuova edizione italiana a cura di Maurizio Ferraris e Pietro Kobau
Titolo del frammento :
I forti dell'avvenire ( 898 )
(Bompiani, 1992)
Traduzione: Angelo Treves (1927, per la casa editrice Monanni, Milano, prima edizione italiana autorizzata, Volume 9, La volontà di potenza)
trad. rivista da Pietro Kobau (1992)
§§§§§§§§§§§§
I forti dell'avvenire
« Ciò che è stato individuato qua e là, in parte dalla necessità, in parte dal caso, e cioè le condizioni propizie al prodursi di una specie più forte : è quanto siamo ormai in grado di capire e di volere consapevolmente : noi possiamo produrre le condizioni che consentono tale innalzamento.
«Fino ad oggi, l'educazione aveva come obiettivo esclusivo il bene della società : non già il maggior bene possibile per il bene possibile per il futuro, bensì solo quello per la società esistente. Per essa si cercavano solo degli "strumenti".
Ammesso che la ricchezza di forze sia maggiore, si potrebbe concepire una sottrazione di forze il cui scopo fosse il bene non più della società, ma del futuro, - questo sarebbe il compito da porsi, una volta capito in che senso la forma attuale della società si trovi impegnata in una poderosa trasformazione che la condurrà a non poter più esistere per se stessa, bensì soltanto quale mezzo in possesso di una razza più forte.
« La mediocrità crescente dell'essere umano è appunto la forza che ci induce a pensare all'addestramento di una razza più forte, la quale troverebbe il suo eccedente proprio in ciò che rende più debole la specie già mediocre (volontà, responsabilità, sicurezza di sé, potersi fissare degli scopi).
« I mezzi sarebbero quelli insegnati dalla storia : l'isolamento mediante interessi di conservazione, all'inverso di quelli che oggi formano la media : l'esercizio dei valori invertiti; la distanza in quanto pathos; la libera coscienza in tutto quanto è oggi meno stimato e più biasimevole.
« L'ugualizzazione dell'uomo europeo è attualmente il grande processo irreversibile, e si dovrebbe anche accelerarlo.
« Da ciò, la necessità di scavare una fossa, di creare una distanza, una gerarchia, e non già la necessità di rallentare il processo.
« Questa specie ugualizzata, una volta che si sia realizzata, esigerà una giustificazione : che è appunto quella di servire a una specie sovrana, la quale si fonda su quella che l'ha preceduta e solo perciò può innalzarsi al proprio compito. Non solo una razza di padroni che si limitino a governare, bensì una razza che abbia la propria sfera di vita, un eccedente di forza per la bellezza, il coraggio, la cultura, le maniere anche in quello che vi è di più spirituale; una razza affermativa che può concedersi qualunque lusso... abbastanza potente da non aver bisogno né della tirannia dell'imperativo di virtù, né della parsimonia, né della pedanteria, al di là del bene e del male : che formi una serra di piante rare e singolari ».
Pierre Klossowski - Nietzsche e il circolo vizioso
(Adelphi, 1981) -
[ ed. orig. fr. Mercure de France, 1969 ]
Traduzione dal tedesco: Pierre Klossowski (1969)
Traduzione dal francese: Enzo Turolla (1981)
La nota dell'editore (Adelphi), presente nell'edizione originale del 1981 di 'Nietzsche e il circolo vizioso' afferma quanto segue:
" La traduzione klossowskiana dei testi di Nietzsche è legata in modo indissolubile all'interpretazione che di quei testi viene qui proposta. A tali traduzioni ci siamo perciò attenuti. "
Il frammento 'I forti dell'avvenire' è basato sul testo originale nietzscheano, tratto dai quaderni autografi di Nietzsche e presentati nella seguente edizione:
Friedrich Nietzsche - Frammenti postumi 1887-1888
Volume VIII, tomo II delle « Opere di Friedrich Nietzsche »
Edizione italiana condotta sul testo critico stabilito da Giorgio Colli e Mazzino Montinari.
§ § § § § § § § § § §
Die Starken der Zukunft. - 9 [ 153 ] (105)
Was theils die Noth, theils der Zufall hier und da erreicht hat, die Bedingungen zur Hervorbringung einer stärkeren Art : das können wir jetzt begreifen und wissentlich wollen : wir können die Bedingungen schaffen, unter denen eine solche Erhöhung möglich ist.
Bis jetzt hatte die «Erziehung» den Nutzen der Gesellschaft
im Auge : nicht den möglichsten Nutzen der Zukunft,
sondern den Nutzen der gerade bestehenden Gesellschaft.
«Werkzeuge» für sie wollte man. Gesetzt, der Reichthum an Kraft wäre größer, so ließe sich ein Abzug von Kräften denken, dessen Ziel nicht dem Nutzen der Gesellschaft gälte, sondern einem zukünftigen Nutzen, -
Eine solche Aufgabe wäre zu stellen, je mehr man begriffe, inwiefern die gegenwärtige Form der Gesellschaft in einer starten Verwandlung wäre, um irgendwann einmal nicht mehr um ihrer selber willen existiren zu können : sondern nur noch als Mittel in den Händen einer stärkeren Rasse.
Die zunehmende Verkleinerung des Menschen ist gerade die
treibende Kraft, um an die Züchtung einer stärkeren Rasse zu denken : welche gerade ihren Überschuß darin hätte, worin die verkleinerte Species schwach und schwächer würde (Wille, Verantwortlichkeit, Selbstgewißheit, Ziele-sich-setzen-können).
Die Mittel wären die, welche die Geschichte lehrt : die Isolation durch umgekehrte Erhaltung-Interessen, als die durchschnittlichen heute sind ; die Einübung in umgekehrten
Werthschätzungen ; die Distanz als Pathos ; das freie Gewissen im heute Unterschätztesten und Verbotensten.
Die Ausgleichung des europäischen Menschen ist der große Prozeß, der nicht zu hemmen ist : man sollte ihn noch beschleunigen.
Die Notwendigkeit für eine Kluftaufreißung, Distanz, Rangordnung ist damit gegeben : nicht die Notwendigkeit, jenen Prozeß zu verlangsamen.
Diese ausgeglichene Species bedarf, sobald sie erreicht ist, einer Rechtfertigung : sie liegt im Dienste einer höheren souveränen Art, welche auf ihr steht und erst auf ihr sich zu ihrer Aufgabe erheben kann.
Nicht nur eine Herren-Rasse, deren Aufgabe sich damit erschöptfe, zu regieren : sondern ein Rasse mit eigener Lebenssphäre, mit einem Überschß von Kraft für Schönheit, Tapferkeit, Kultur, Manier bis in's Geistigste ; eine bejahende Rasse, welche sich jeden großen Luxus gönnen darf -, stark genug, um die Tyrannei des Tugend-Imperativs nicht nöthig zu haben, reich genug, um die Sparsamkeit und Pedanterie nicht nöthig zu haben, jenseits von Gut und Böse ; ein Treibhaus für sonderbare und ausgesuchte Pflanzen.
Friedrich Nietzsche - Sämtliche Werke
Kritische Studienausgabe - Band 12
DTV de Gruyter
Nachgelassene Fragmente 1885 - 1889
1. Teil : 1885 - 1887
Read more @ Nietzsche Source
§§§§§§§§§§§§§
WM 898 (Spring-Fall 1887)
The strong of the future.-
That which partly necessity, partly chance has achieved here and there, the conditions for the production of a stronger type, we are now able to comprehend and consciously will: we are able to create the conditions under which such an elevation is possible.
Until now, "education" has had in view the needs of society: not the possible needs of the future, but the needs of the society of the day. One desired to produce "tools" for it. Assuming the wealth of force were greater, one could imagine forces being subtracted, not to serve the needs of society but some future need.
Such a task would have to be posed the more it was grasped to what extent the contemporary form of society was being so powerfully transformed that at some future time it would be unable to exist for its own sake alone, but only as a tool in the hands of a stronger race.
The increasing dwarfing of man is precisely the driving
force that brings to mind the breeding of a stronger race—a race that would be excessive precisely where the dwarfed
species was weak and growing weaker (in will,
responsibility, self-assurance, ability to posit goals
for oneself ).
The means would be those history teaches: isolation through interests in preservation that are the reverse of those which are average today; habituation to reverse evaluations; distance as a pathos; a free conscience in those things that today are most undervalued and prohibited.
The homogenizing of European man is the great process that cannot be obstructed: one should even hasten it.
The necessity to create a gulf, distance, order of rank, is given eo ipso--not the necessity to retard the process.
As soon as it is established, this homogenizing species reguires a justification: it lies in serving a higher sovereign species that stands upon the former and can raise itself to its task only by doing this.
Not merely a master race whose sole task is to rule, but a race with its own sphere of life, with an
excess of strength for beauty, bravery, culture, manners to
the highest peak of the spirit; an affirming race that may
grant itself every great luxury — strong enough to have no
need of the tyranny of the virtue-imperative, rich enough to have no need of thrift and pedantry, beyond good and evil; a hothouse for strange and choice plants .
Friedrich Nietzsche - The Will of Power
Translated by Walter Kaufmann and R.J. Hollingdale
Edited by Walter Kaufmann (Copyright, 1967)
Random House, New York, 1967
or Vintage Books Edition (September 1968)
or Knopf Doubleday Publishing Group (2011, pg. 478)
Picblog: Anthony p. Iannini 'Nietzsche' (2005)