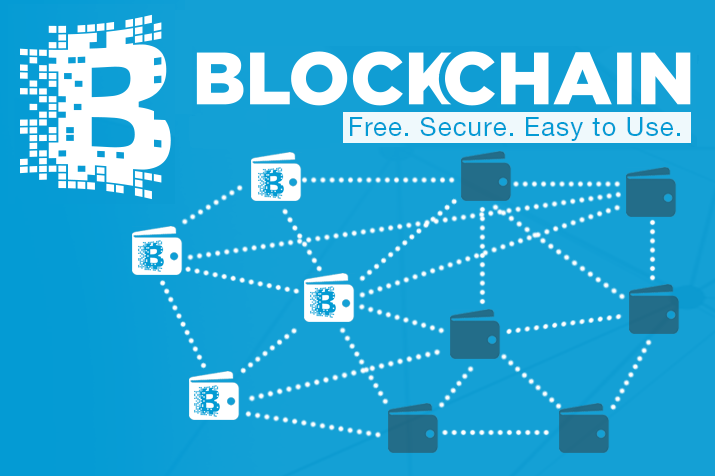E' finalmente disponibile online l'antologia e.book curata dal collettivo Obsolete Capitalism intitolata «Moneta, rivoluzione e filosofia dell'avvenire. Nietzsche e la politica accelerazionista in Deleuze, Foucault, Guattari, Klossowski» (Edizioni Rizosfera/Obsolete Capitalism Free Press, 2016).
Clicca QUI Free Download - E.book
Gli autori sono: Algorithmic Committee, Sara Baranzoni, Edmund Berger, Lapo Berti, Paolo Davoli, Ettore Lancellotti, Network Ensemble, Obsolete Capitalism, Obsolete Capitalism Sound System, Letizia Rustichelli, Francesco Tacchini, Paolo Vignola.
Moneta, rivoluzione e filosofia dell’avvenire
a cura di Obsolete Capitalism
Siamo proiettati a velocità fotonica nella comunicazione istantanea e nel controllo continuo mentre le forme di dominio rapido appaiono inarrestabili. Il museo delle ideologie si riempie di concetti in via di esaurimento quali capitalismo, neoliberismo, marxismo, keynesismo. Ora, con più esattezza, il sistema modula i vari flussi che innervano il pianeta: Moneta, Ricerca, Controllo, Informazione, Circuito sono i vecchi nomi che attraverso una nuova velocità producono potere. Maggiore è l’immanenza del Mercato, maggiore è la probabilità che al conflitto si sostituisca l’interruzione, il virus, la fuga di notizie, l’invisibilità, il fuori-circuito, la biforcazione. Uno squarcio nella «zona grigia» dell’egemonia.
Gli autori del libro Moneta, rivoluzione e filosofia dell’avvenire indagano alcune aree poco battute di politica accelerazionista attraverso linee teoriche contagiate dalle filosofie più visionarie: Nietzsche, Klossowski, Deleuze, Guattari, Foucault. Più che analizzare la grande trasformazione culturale in atto, la presente antologia evidenzia i pericoli in cui incorre il pensiero del futuro quando ancora mantiene pratiche, schemi e linguaggi di un’epoca industriale e post-industriale che mostra in tutti i suoi aspetti una crisi perpetua. Siamo tutti coinvolti nel duro intreccio di liberazioni insperate e nuovi asservimenti che ci prospetta la presentificazione del futuro da parte della tecnologia a linguaggio numerico, ma - come afferma Deleuze - «non è il caso né di avere paura, né di sperare, bisogna cercare nuove armi». Sperimentare è dunque il primo impegno politico e filosofico per un futuro differente.