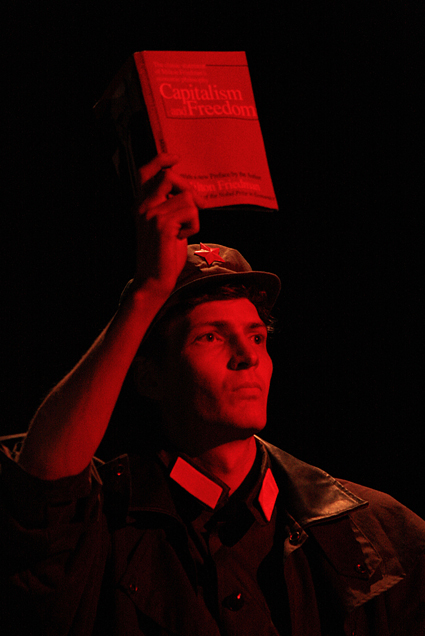Il lavoro seminariale raccolto in questo volume prende spunto dal frammento Capitalismo come religione, composto da Benjamin nel 1921. Qui, in poche pagine dalla densità quasi visionaria, il capitalismo è presentato come una religione puramente cultuale, che tende a reiterare all’infinito un meccanismo di indebitamento e di colpevolizzazione da cui non può esserci scampo. A distanza di quasi un secolo, l’intuizione di Benjamin risulta confermata in maniera plateale dalla crisi dei nostri giorni, e non c’è da stupirsi se il frammento è diventato ormai un riferimento costante nei dibattiti recenti sulla natura e sul destino del capitalismo.
Per queste ragioni l’Associazione Italiana Walter Benjamin (AWB) ha scelto questo breve testo per inaugurare le pubblicazioni del suo Seminario permanente, affiancando a una nuova traduzione del frammento i contributi dei diversi autori che hanno preso parte al primo ciclo di incontri. Questo lavoro vorrebbe contribuire ad avviare una fase nella ricezione dell’opera di Benjamin interessata soprattutto a farne emergere lo straordinario valore per una comprensione critica dell’attualità.
Contributi di Alessandra Campo, Roberto Ciccarelli, Massimo De Carolis, Dario Gentili, Gabriele Guerra, Clemens-Carl Härle, Giuseppe Massara, Bruno Moroncini, Paolo Napoli, Massimo Palma, Mauro Ponzi, Sarah Scheibenberger, Elettra Stimilli, Tamara Tagliacozzo, Massimiliano Tomba, Luca Viglialoro.
§§§§§
Il culto del capitalePaolo Godani «Alfabeta2» 06-12-2014
Il culto del capitale, che comprende una nuova traduzione del testo di Benjamin Kapitalismus als Religion e una quindicina di saggi dedicati a temi connessi, è il risultato di un lavoro comune svolto nel Seminario permanente di Studi benjaminiani (istituito dall’Associazione Walter Benjamin). Soprattutto la prima parte del testo (che oltre ai contributi dei curatori vede quelli di Massimiliano Tomba, Bruno Moroncini e Clemens-Carl Härle) è legata all’analisi del frammento benjaminiano e alla ricostruzione dei contesti storici e teorici nei quali esso si inserisce. Nella seconda parte del lavoro sono presentati testi (di Paolo Napoli, Massimo De Carolis, Roberto Ciccarelli e Alessandra Campo) che elaborano in maniera più autonoma alcune delle tematiche suggerite nello scritto di Benjamin, facendo emergere soprattutto la loro centralità per una comprensione critica del mondo attuale. Infine, la terza parte del libro (con testi di Luca Viglialoro, Sarah Scheinbenberger, Gabriele Guerra, Tamara Tagliacozzo, Massimo Palma, Giuseppe Massara) è dedicata all’analisi di incontri (reali o possibili) tra Benjamin e altri pensatori o poeti per lo più novecenteschi (ad esempio: Sorel, Bataille, Eliot, Pasolini).
Alcune delle linee direttrici che segue Il culto del capitale erano state anticipate dal libro di Stimilli, Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo (Quodlibet 2011), senza che ciò diminuisca l’interesse di questo studio collettivo ricco e approfondito. Nell’impossibilità di rendere conto in maniera dettagliata dei diversi contributi, ci limiteremo a segnalare alcune delle tematiche a nostro avviso più interessanti.
Innanzitutto, il confronto tra la prospettiva di Benjamin e quella di Max Weber e di Carl Schmitt. Con il primo, da cui evidentemente Kapitalismus und Religion trae (seppure in maniera critica) il suo spunto centrale, Benjamin condivide l’idea che all’origine del potere religioso dell’economia capitalistica non vi sia la teologia, ma la pratica dell’ascetismo cristiano. Con il secondo, Benjamin ha in comune, fra l’altro, la considerazione della colpa come nozione-limite del diritto, in questo assimilabile al forza con la quale la legge si impone. Per Benjamin la colpa (Schuld), esterna o liminare rispetto al potere politico, è tuttavia interna, nella forma del debito (Schulden), ad un potere economico che si presenta dunque come una modalità di dominio distinta dal potere statuale, ma forse addirittura più violenta (in quanto più sottilmente pervasiva) di quest’ultimo.
Uno dei punti più rilevanti è che il “portatore” della colpa, dunque l’indebitato nel quale si incarna la forma generatrice dal capitalismo, non è il vivente umano in generale, ma l’individuo vivente. Il potere religioso del capitale non si applica all’uomo generico o alla massa degli uomini, bensì a ogni singolo essere umano come tale. Il culto colpevolizzante e indebitante del capitale è anche, inseparabilmente, un culto individualizzante, il cui sintomo Benjamin identifica, con grande raffinatezza psicologica, in quella “malattia dello spirito proprio dell’epoca capitalistica” che sono le “preoccupazioni”. Queste ultime sono sintomo dell’individualizzazione perché “sorgono dall’angoscia per l’assenza di una via d’uscita che sia comunitaria e non individuale-materiale” (p. 11). Se questo è vero, la via d’uscita (dalle preoccupazioni e dal capitalismo) dovrà procedere – come spiega Gentili – “in senso inverso rispetto all’individualizzazione, alla frantumazione dell’inter-esse in interesse individuali”. In altre parole, “Benjamin non sta sostenendo soltanto la condivisibilità del debito. Egli sostiene soprattutto che, in sé, la vita in-comune è priva di colpa” (p. 67).
Questa necessaria inversione di rotta, questa Umkehr, viene messa da Benjamin in opposizione esplicita al potenziamento (Steigerung) che si suppone caratteristico dell’oltreuomo nietzschiano. La via d’uscita dal capitalismo non sta nel potenziamento dell’umano, ma, giusto all’opposto, nella politica come “adempimento dell’umanità non potenziata (ungesteigerten)” (p. 68). La nozione di Umkehr, come viene suggerito da Härle nel suo testo, torna sotto la penna di Benjamin nel saggio su Kafka, dove si afferma che essa consiste nella “direzione dello studio che trasforma la vita in scrittura”, dove lo studio, “poiché non si oggettiva in alcuna cosa né in alcun prodotto – commenta Härle – si riassume nella semplice intensità del suo gesto” (p. 103).
Il nesso tra l’inversione di rotta rispetto all’individualizzazione e il culto capitalistico che fa pesare sull’individuo il destino di una colpa inespiabile, di un debito infinito, spiega forse l’accenno di Benjamin al fatto che “la teoria freudiana appartiene al dominio sacerdotale di questo culto” (p. 10). Il culto del capitale sorvola discretamente questo punto, che sarebbe stato utile mettere in relazione con la considerazione benjaminiana di una nozione di carattere opposta all’idea di destino.
Varrebbe la pena approfondire l’idea che una via d’uscita dalla colpa costitutiva del destino individuale non si trovi nell’immagine di un rimosso come “capitale che grava di interessi l’inferno dell’inconscio” (immagine che, semmai, ribadisce la costituzione di un’individualità colpevole), non, dunque, nella psicanalisi, ma piuttosto in quella “sublimità della commedia di carattere” che risiede nell’affermazione di una certa “anonimità dell’uomo e della sua moralità, pur mentre l’individuo si dispiega al massimo nell’unicità del suo tratto caratteristico” (Destino e carattere).
Il culto del capitale mostra nella maniera più chiara sino a che punto, per invertire la rotta del capitalismo attuale, le pratiche volte a rimuovere il peso economico del debito non possano non affrontare il problema dell’eliminazione del fardello antropologico della colpa.