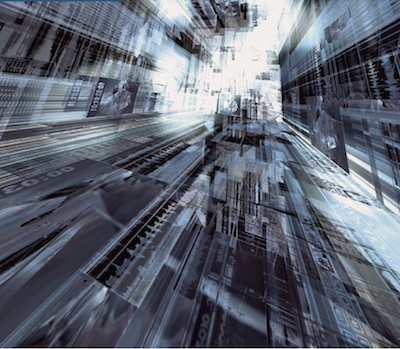Gli algoritmi del capitale
Recensione di Elettra Stimilli per Alfabeta2, 3 giugno 2015
Quando era appena uscito nelle sale italiane The Wolf of Wall Street, il film in cui Scorsese narra l'ascesa e la caduta di uno dei tanti spregiudicati broker newyorkesi, nell'intenzione - da lui stesso esplicitamente dichiarata - di “scoprire come lavorano le loro menti”, viene pubblicato in Italia un volume a cura di Matteo Pasquinelli, Gli algoritmi del capitale. Accelerazionismo, macchine delle conoscenza e autonomia del comune (Ombre Corte 2014), che tenta di inscrivere la riflessione sull'attuale crisi finanziaria tra le sofisticate pieghe della virtualizzazione della finanza e delle relazioni sociali. Più che al film di Scorsese, Pasquinelli preferisce, però, far riferimento, come antecedente artistico delle analisi contenute nel libro da lui curato, al romanzo di Don DeLillo Cosmopolis, scritto negli stessi anni del movimento di Seattle e prima del tragico attacco alle Twin Towers.
Muovendo da una riflessione sul predominio e sulla crisi del capitalismo finanziario contemporaneo, i saggi raccolti in questo volume sono tutti accomunati dall'esigenza di guardare all'orizzonte tecnologico globale nell'intento di trovare nuovi paradigmi in grado di dischiudere differenti spazi collettivi e politici. Il volume si apre con il Manifesto per una politica accelerazionista di Alex Williams e Nick Srnicek, da molti definito il caso editoriale del 2013 all'interno del pensiero politico radicale. Sorto dall'ambiente intellettuale che ruota attorno alla rivista inglese «Collapse» - spesso individuato con l'etichetta “realismo speculativo” e legato ad autori come Reza Negarestani e Ray Brassier – il Manifesto è stato tradotto in diverse lingue e viene qui presentato in versione italiana come un'introduzione al dibattito che si è sviluppato a partire da un simposio organizzato a Berlino nel 2013.
Le tesi del Manifesto possono così essere confrontate con quelle che provengono dalle riflessioni dell'operaismo italiano che, già negli anni Settanta del secolo scorso, aveva saputo mettere a tema l'egemonia del general intellect nelle società post-fordiste, evidenziando il graduale predominio del lavoro cognitivo. Oggi tuttavia, come scrive Pasquinelli nell'Introduzione, “non è sufficiente affermare che il capitalismo [...] [sia] un capitalismo cognitivo […]. Il capitalismo ha sviluppato forme di intelligenza autonoma e di scala superiore. Si deve dire: il capitale stesso pensa” (p. 9). Il piano di sorveglianza PRISM della National Security Agency, di recente divenuto famoso grazie allo scandalo sulle intercettazioni che ha coinvolto le agenzie di intelligenceamericane - di cui, tra l'altro, si tratta in Citizenfour, il film documentario di Laura Poitras su Edward Snowden, di recente diffuso anche nelle sale cinematografiche italiane - ha rivelato in maniera palese questa situazione.
Se questo automaton tecnologico planetario sta ridisegnando i confini del nuovo nomos politico, a nulla possono servire nostalgiche visioni di un passato ormai irrecuperabile. Per gli autori del Manifesto accelerazionista si tratta piuttosto di portare all'estremo questa orientamento come attendendo una sua implosione interna, che sia, però, l'inizio per una nuova era post-capitalistica. L'accelerazione risulta in questo senso la realizzazione di tendenze che dovrebbero condurre al pieno dispiegamento di potenzialità già contenute, ma neutralizzate, nell'attuale forma del capitalismo.
Una simile analogia tra l'impero globalizzante della politica post-nazionale e le potenzialità della rete è presente anche nella prospettiva di Antonio Negri, che interviene insieme ad altri nel volume (come Franco Berardi Bifo, Mercedes Bunz, Stefano Harney, Tiziana Terranova, Carlo Vercellone, Cristiana Marazzi, ecc.). Ma il problema, per Negri, non è soltanto il fatto che “accelerazionismo” risulta un termine infelice, perché richiama “un senso futurista a quello che futurista non è” (p. 34); ma soprattutto sta nella possibilità di ricondurre questo processo alla sua organizzazione politica, alle stesse forze sociali preesistenti a qualsiasi “algoritmo” del capitale.
Matteo Pasquinelli (a cura di)
Gli algoritmi del capitale
Accelerazionismo, macchine della conoscenza e autonomia del comune
ombre corte (2014), pp. 187
Gli algoritmi del capitale
Accelerazionismo, macchine della conoscenza e autonomia del comune
ombre corte (2014), pp. 187