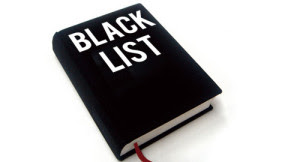We live in an information society in which data has become a commodity; we offer Data Mining from a Post-Marxist Perspective (We're sorry about the visual noise but we're in our Metal Box In Dub era).
Visualizzazione post con etichetta Benedetto XVI. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Benedetto XVI. Mostra tutti i post
martedì 4 giugno 2013
Antonio Gnoli: Il mistero del male di Giorgio Agamben sulla scelta radicale di Ratzinger @ La Repubblica, 14 maggio 2013 (recensione del libro Il mistero del male di Giorgio Agamben)
Un oscuro teologo del IV secolo fa da sfondo dottrinale alla decisione del Papa di abdicare al suo magistero. Possibile? Ce lo racconta con il solito raffinato incastro di testi Giorgio Agamben nel nuovo libro: Il mistero del male (Laterza). Da anni egli affronta il significato politico della fine dei tempi, sfrondandolo dagli orpelli apocalittici e cogliendone il senso in una plausibile ricerca filologica. I testi a volte ci parlano: nella loro autorevolezza sopportano l’usura del tempo e ci indicano strade che avevamo abbandonato. Non è questo il senso della tradizione, di quella sapienza archeologica che segna a volte il nostro agire più consapevole?
Proprio Joseph Ratzinger, appena trentenne, pubblicò un dotto articolo per spiegare la posizione dottrinaria di Ticonio in merito alla Chiesa. Costui era un donatista che avendo descritto una Chiesa al tempo stesso malvagia e giusta, seppe coglierne la struttura bipartita che comprende in sé tanto il peccato quanto la grazia. In una prospettiva escatologica questi due corpi della Chiesa sono destinati a convivere fino alla fine dei tempi. Allorché il Giudizio universale dividerà definitivamente i malvagi dai giusti, il Cristo dall’Anticristo. Fino a quel momento le due “anime” conserveranno una loro presenza nello stesso corpo della Chiesa. È in questo contesto teologico che Agamben colloca il gesto rivoluzionario di Benedetto XVI. Che non è un atto di viltà – accusa già rivolta a Celestino V – né di stanchezza, ma una meditata e sofferta scelta dottrinaria che lo ha posto all’altezza della drammatica situazione in cui la Chiesa si trova a vivere.
Può, infatti, questo istituto millenario attendere che il gran conflitto tra i malvagi e i giusti si risolva alla fine dei tempi? Ecco perché la prospettiva escatologica va ricondotta a quella storica, il tempo dell’apocalisse al nostro tempo. La Chiesa, ci rammenta Agamben, non può sopravvivere se rimanda passivamente alla fine dei tempi la soluzione del conflitto che ne dilania il “corpo bipartito”. D’altro canto, l’aver ignorato lo sguardo escatologico ha pervertito l’azione salvifica della Chiesa nel mondo. L’ha resa per così dire cieca e priva di scopo. Di qui gli scandali, la corruzione e quel corredo negativo che ne hanno stravolto l’immagine. Agamben sottrae il male al cupo dramma teologico e lo restituisce al suo vero contesto storico, nel cui spazio ognuno è chiamato a fare senza riserve la sua parte. Decidere, d’accordo. Ma su cosa? E per quali opzioni o scelte?
Benedetto XVI suggerisce una strada. La sua decisione radicale rinvigorisce l’idea di giustizia e di legittimità. Rimette in moto una macchina politica senza la quale la Chiesa sarebbe destinata a inabissarsi. Non è di un analogo destino che soffre la nostra società? Ancora una volta teologia e politica incrociano due categorie – legittimità e legalità – oggi confuse o smarrite. La profondità della crisi che la nostra società sta attraversando, dice Agamben, va ricondotta anche al tentativo della modernità di far coincidere legalità e legittimità.
Una Chiesa dei giusti non trionferà senza una lotta ai malvagi; così come una società equa non prevarrà senza il ricorso alla giustizia che è un concetto più profondo della legalità. Chi può avere oggi la forza di trasferire nel profano ciò che Benedetto XVI – con il suo richiamo all’Auctoritas (al potere spirituale) – ha svolto nell’ambito del teologico? Le nostre vite, attraversate da crisi terribili, hanno urgenze mondane che si scontrano con l’ideologia liberista oggi dominante. Nota Agamben che il paradigma del mercato autoregolantesi si è sostituito a quello della giustizia e finge di poter governare una società sempre più ingovernabile secondo criteri esclusivamente tecnici. Chiamiamola pure dittatura dell’algoritmo. Ma chi oggi ha un potere così immenso da potervi perfino abdicare? Non è da questa rinuncia che possa nascere una nuova occasione per la politica. Perché il potere sembra esser sfuggito dalle mani dell’uomo. Ecco il dramma storico e il “mistero” dal quale bisogna ripartire.
Read more @ La Repubblica website
Picblog: See more
domenica 2 giugno 2013
Giorgio Agamben - Il mistero del male Benedetto XVI e la fine dei tempi - Laterza, It, 2 maggio 2013 + Recensioni: Alfonso Berardinelli @ Il Foglio e Paolo Vernaglione @ Il Manifesto
Il mistero del male
Benedetto XVI e la fine dei tempi
Compiendo il ‘gran rifiuto’, Benedetto XVI ha dato prova non di viltà, ma di un coraggio che acquista oggi un senso e un valore esemplari. La sua decisione richiama con forza l’attenzione sulla distinzione fra due principi essenziali della nostra tradizione etico-politica, di cui le nostre società sembrano aver perduto ogni consapevolezza: la legittimità e la legalità. Se la crisi che la nostra società sta attraversando è così profonda e grave, è perché essa non mette in questione soltanto la legalità delle istituzioni, ma anche la loro legittimità; non soltanto, come si ripete troppo spesso, le regole e le modalità dell’esercizio del potere, ma il principio stesso che lo fonda e legittima.
Il ‘mistero del male’, di cui parla l’apostolo Paolo, non è un cupo dramma teologico che trattiene la fine dei tempi e paralizza e rende enigmatica e ambigua ogni azione, ma un dramma storico in cui l’Ultimo Giorno coincide col presente e in cui ciascuno è chiamato a fare senza riserve e senza ambiguità la sua parte.
Il ‘mistero del male’, di cui parla l’apostolo Paolo, non è un cupo dramma teologico che trattiene la fine dei tempi e paralizza e rende enigmatica e ambigua ogni azione, ma un dramma storico in cui l’Ultimo Giorno coincide col presente e in cui ciascuno è chiamato a fare senza riserve e senza ambiguità la sua parte.
L’utopia comunista ha bisogno di santi, Agamben ha trovato
B-XVI di Alfonso Berardinelli @ Il Foglio, 29 maggio 2013
B-XVI di Alfonso Berardinelli @ Il Foglio, 29 maggio 2013
Cercherò di riassumere, per quanto mi è possibile e in breve, il chiarimento teologico-politico che Giorgio Agamben ci ha offerto nel suo saggio “Il mistero del male. Bendetto XVI e la fine dei tempi” (Laterza, 67 pp., euro 7). Agamben, come sanno i suoi lettori, oltre che il nostro maggiore editore e studioso di Walter Benjamin, è un pensatore politico internazionalmente noto per la sua originalità, nonché un profondo conoscitore della teologia cristiana. E della teologia (come suggerì Benjamin) non ha mai sottovalutato il contenuto storico e politico, la sua pervasiva benché sotterranea influenza sulla cultura laica moderna. L’erudizione teologica viene usata da Agamben per mostrare, rivelare le tracce di una presenza culturale rimossa dal pensiero illuministico, eppure tuttora attiva nelle forme in cui ci si presenta oggi la crisi del mondo contemporaneo.
Perciò, se importa chiarire il significato teologico e politico della rinuncia di papa Ratzinger, è perché tanto nella chiesa quanto nella società attuale viene vissuto, secondo Agamben, un medesimo “dramma storico”, nel quale si oppongono Cristo e Anticristo, economia ed escatologia, diritto formale e giustizia sostanziale, legalità e legittimità.
Nell’ultimo paragrafo del primo saggio, “Il mistero della chiesa”, Agamben scrive: “Abbiamo cercato di interpretare l’esemplarità del gesto di Benedetto XVI nel contesto teologico e ecclesiologico che le è proprio. Ma se questo gesto ci interessa, non è certo soltanto nella misura in cui rimanda a un problema interno alla chiesa, quanto piuttosto perché esso permette di mettere a fuoco un tema genuinamente politico, quello della giustizia che, al pari della legittimità, non può essere eliminato dalla prassi della nostra società. Noi sappiamo perfettamente che anche il corpo della nostra società politica è, come quello della chiesa e forse ancora più gravemente, bipartito, commisto di male e di bene, di crimine e di onestà, di ingiustizia e giustizia. E tuttavia, nella prassi delle democrazie moderne, questo non è un problema politico e sostanziale, ma giuridico e procedurale. Anche qui, come è avvenuto per il problema della legittimità, esso viene liquidato sul piano delle norme che vietano e puniscono, salvo dover poi constatare che la bipartizione del corpo sociale diventa ogni giorno più profonda. Nella prospettiva dell’ideologia liberista oggi dominante, il paradigma del mercato autoregolantesi si è sostituito a quello della giustizia e si finge di poter governare una società sempre più ingovernabile secondo criteri esclusivamente tecnici”.
Perciò, se importa chiarire il significato teologico e politico della rinuncia di papa Ratzinger, è perché tanto nella chiesa quanto nella società attuale viene vissuto, secondo Agamben, un medesimo “dramma storico”, nel quale si oppongono Cristo e Anticristo, economia ed escatologia, diritto formale e giustizia sostanziale, legalità e legittimità.
Nell’ultimo paragrafo del primo saggio, “Il mistero della chiesa”, Agamben scrive: “Abbiamo cercato di interpretare l’esemplarità del gesto di Benedetto XVI nel contesto teologico e ecclesiologico che le è proprio. Ma se questo gesto ci interessa, non è certo soltanto nella misura in cui rimanda a un problema interno alla chiesa, quanto piuttosto perché esso permette di mettere a fuoco un tema genuinamente politico, quello della giustizia che, al pari della legittimità, non può essere eliminato dalla prassi della nostra società. Noi sappiamo perfettamente che anche il corpo della nostra società politica è, come quello della chiesa e forse ancora più gravemente, bipartito, commisto di male e di bene, di crimine e di onestà, di ingiustizia e giustizia. E tuttavia, nella prassi delle democrazie moderne, questo non è un problema politico e sostanziale, ma giuridico e procedurale. Anche qui, come è avvenuto per il problema della legittimità, esso viene liquidato sul piano delle norme che vietano e puniscono, salvo dover poi constatare che la bipartizione del corpo sociale diventa ogni giorno più profonda. Nella prospettiva dell’ideologia liberista oggi dominante, il paradigma del mercato autoregolantesi si è sostituito a quello della giustizia e si finge di poter governare una società sempre più ingovernabile secondo criteri esclusivamente tecnici”.
Queste deduzioni hanno il pregio della chiarezza, della semplicità e della radicalità dottrinale. Male e bene convivono e si oppongono nella chiesa come nella società capitalistica. Il gesto esemplare di rinuncia compiuto da Ratzinger ha voluto rendere il più possibile evidente l’esigenza di marcare l’opposizione fra ciò che nella chiesa appartiene al mondo e al suo dominatore Satana e ciò che appartiene a Cristo. La chiesa nasce e vive nel mondo, ma non appartiene al mondo. La sua “economia” non può sovrastare e sopprimere la sua “escatologia”, cioè il manifestarsi nella coscienza morale di un tempo messianico che non è “l’ultimo giorno” e la “fine del tempo”, ma “che è in corso per così dire in ogni istante”.
Ratzinger dimissionario, dunque, come “figura” teologica ed ecclesiologica di una rivoluzione sociale legittima. Non si può a questo punto non pensare al “tempo-ora” di Benjamin, al suo messianismo rivoluzionario, alla sua idea di un’interruzione del continuum storico e del progressismo riformista che frenano e paralizzano l’avvento della giustizia.
Agamben procede con ogni cautela filologica quando si tratta di esegesi teologica e quando ricorda le tappe della vicenda intellettuale di Ratzinger, a partire dalla sua interpretazione giovanile di un testo del grande teologo Ticonio, attivo nel IV secolo in Africa, fino al suo discorso del 28 aprile 2009 a L’Aquila sulla tomba di Celestino V, che secondo Dante fece “per viltade il gran rifiuto”. Mi sembra però che nel passaggio dall’ecclesiologia al messianismo politico Agamben non si mostri altrettanto cauto. In termini teologici si può credere di sapere cos’è Cristo e cosa l’Anticristo, ma in termini sociali e politici la “bipartizione del corpo sociale” che “diventa ogni giorno più profonda” è molto meno chiara. I rapporti fra legalità, economia, legittimità politica, giustizia sociale, prassi e potere rivoluzionari sono stati il problema tragicamente irrisolto dal 1789 ai comunismi del XX secolo. Sulla teoria della rivoluzione e sull’avvento della giustizia Agamben resta piuttosto reticente. Nella sua strategia argomentativa attuale mi sembra che venga compiuto un rovesciamento del rapporto che Benjamin istituì tra teologia e materialismo storico in una delle sue più note “Tesi di filosofia della storia”. Alla fine degli anni Trenta, secondo Benjamin, la teologia era culturalmente impresentabile e doveva restare nascosta per manovrare l’armamentario concettuale del marxismo, allora in voga. Oggi succede il contrario. La teologia ha vinto, sembra aver conquistato e colonizzato i comunisti utopico-rivoluzionari. Perciò Agamben può essere del tutto esplicito e filologicamente documentato finché parla da teologo, ma deve mantenere velata una poco presentabile utopia comunista, per sostenere la quale si è da tempo sprovvisti di teoria. Così viene delegata al clamoroso gesto dimissionario di un Papa la responsabilità morale e teologica di alludere alla perenne attualità della rivoluzione come “parusia”, come avvento del bene essenziale o del regno di Dio nel mondo.
Ratzinger dimissionario, dunque, come “figura” teologica ed ecclesiologica di una rivoluzione sociale legittima. Non si può a questo punto non pensare al “tempo-ora” di Benjamin, al suo messianismo rivoluzionario, alla sua idea di un’interruzione del continuum storico e del progressismo riformista che frenano e paralizzano l’avvento della giustizia.
Agamben procede con ogni cautela filologica quando si tratta di esegesi teologica e quando ricorda le tappe della vicenda intellettuale di Ratzinger, a partire dalla sua interpretazione giovanile di un testo del grande teologo Ticonio, attivo nel IV secolo in Africa, fino al suo discorso del 28 aprile 2009 a L’Aquila sulla tomba di Celestino V, che secondo Dante fece “per viltade il gran rifiuto”. Mi sembra però che nel passaggio dall’ecclesiologia al messianismo politico Agamben non si mostri altrettanto cauto. In termini teologici si può credere di sapere cos’è Cristo e cosa l’Anticristo, ma in termini sociali e politici la “bipartizione del corpo sociale” che “diventa ogni giorno più profonda” è molto meno chiara. I rapporti fra legalità, economia, legittimità politica, giustizia sociale, prassi e potere rivoluzionari sono stati il problema tragicamente irrisolto dal 1789 ai comunismi del XX secolo. Sulla teoria della rivoluzione e sull’avvento della giustizia Agamben resta piuttosto reticente. Nella sua strategia argomentativa attuale mi sembra che venga compiuto un rovesciamento del rapporto che Benjamin istituì tra teologia e materialismo storico in una delle sue più note “Tesi di filosofia della storia”. Alla fine degli anni Trenta, secondo Benjamin, la teologia era culturalmente impresentabile e doveva restare nascosta per manovrare l’armamentario concettuale del marxismo, allora in voga. Oggi succede il contrario. La teologia ha vinto, sembra aver conquistato e colonizzato i comunisti utopico-rivoluzionari. Perciò Agamben può essere del tutto esplicito e filologicamente documentato finché parla da teologo, ma deve mantenere velata una poco presentabile utopia comunista, per sostenere la quale si è da tempo sprovvisti di teoria. Così viene delegata al clamoroso gesto dimissionario di un Papa la responsabilità morale e teologica di alludere alla perenne attualità della rivoluzione come “parusia”, come avvento del bene essenziale o del regno di Dio nel mondo.
Il «Mistero del male» di Giorgio Agamben
Fuga dal tempo del dominio
Di Paolo Vernaglione @ Il Manifesto, 29 maggio 2013
Fuga dal tempo del dominio
Di Paolo Vernaglione @ Il Manifesto, 29 maggio 2013
Una riflessione del filosofo italiano sulle dialettiche irrisolte della teologia politica a partire dalle dimissioni di Benedetto XVI
Il materialista storico lo sa, che ognuno è dotato di una debole forza messianica, un’esigenza che non si lascia soddisfare facilmente. Parafrasando il Benjamin della seconda delle Tesi di filosofia della storia, possiamo agevolmente leggere le riflessioni di Giorgio Agamben sulle dimissioni di Papa Bendetto XVI nel Mistero del male (Laterza, euro 7) in cui il primo mistero è contenuto. Il breve e denso testo raccoglie una conferenza tenuta a Friburgo nel 2012 per il conferimento della laurea honoris causa in teologia e un commento al «gran rifiuto» di papa Ratzinger. Il fulcro della tesi di Agamben, che da tempo ha aperto un produttivo campo di indagine sul dispositivo politico del messianesimo, sulla scorta dell’insegnamento di Jacob Taubes, in II tempo che resta, e soprattutto sul rapporto tra regole e prassi, (Opus Dei) e oekonomia e escatologia (La Chiesa e il Regno), è che il gesto di Benedetto XVI si inscrive in quella temperie epocale chiamata presente, che è delimitata da due figure, entrambe decisive per capirne l’ontologia: il katechon (ciò che trattiene) e il messìa (colui che viene nel tempo-ora). Diversamente dall’interpretazione teologico-politica che Carl Schmitt ha reso popolare e seducente, a partire da Agostino si fa strada una lettura del katechon che rimette in asse il dramma del tempo presente come tempo della fine, sganciandolo dall’evocazione della fine dei tempi, in cui una post-storia avrebbe compiuto tutta la prassi possibile, derivandone un tempo dell’inanità di ogni azione innovativa o trasformativa.
Questa seconda linea di lettura era in realtà già operante nelle interpretazioni patristiche che individuano il potere che frena nell’impero e addirittura in Nerone quale personificazione del male assoluto. Sulla base della geniale teologia delle regole di Ticonio nel IV secolo, studiata peraltro da Ratzinger, che prevede il corpo bipartito del Signore e della chiesa (insieme malvagia e onesta), il katechon è uno degli elementi del «mistero dell’iniquità», l’altro essendo la venuta del messìa, preceduta dalla rivelazione dell’anticristo; ma attenzione: mistero non significa opera nascosta, bensì azione drammatica, teatro liturgico; iniquità è la brutta traduzione religiosa di anomìa e l’anticristo non è ciò che si oppone al Cristo, bensì ciò che gli è simile e che si afferma quindi come menzogna, male storico, economico, dentro e non fuori dal teatro escatologico della temporalità. Agamben sposta la figura del katechon da elemento esterno e astratto, figura immobile di una teologia politica che si oppone al male radicale, a forza interna alla chiesa e al mondo, al pari del male radicale. L’errore teologico e politico di considerare il trattenimento e il male come poli di una dialettica del tempo lineare, che si risolvono nella venuta del messìa, sulla scorta della dismissione dell’escatologia sia dal tempo mondano che da quello liturgico — ha consentito una filosofia della prassi reazionaria che, da Carl Schmitt a oggi ha di fatto giustificato la conservazione, il trattenimento della potenza umana di sovversione, in vista di una salvifico e destinale «sol dell’avvenire».
L’abdicazione di papa Ratzinger segna invece il tempo presente mostrando l’anticristo dentro la chiesa e dentro lo Stato e allude ad una prassi in cui il tempo del «già» e del «non ancora», lungi dall’essere separati convivono nell’umana facoltà di linguaggio. Essa, con Benjamin, è naturalmente messianica. Agamben rompe sia con le pretese proceduraliste delle democrazie liberali, ormai illegali, che con le elucubrazioni dialettico-sovraniste e stataliste fondate su una presunta legittimità pura di istituzioni che «trattengono» il male. Si tratta invece di stare dentro il dramma escatologico di questo presente, inventando quotidianamente una prassi che non può se non provenire da una facoltà dispiegata di linguaggio in cui il passato metastorico si risolve nella storica realtà del presente.
Artist: Stelios Faitakis: Read and See more
giovedì 14 febbraio 2013
Nadia Francalacci: Dimissioni Benedetto XVI: vecchiaia o complotto? @ Panorama, 14 febbraio 2013
Dimissioni Benedetto XVI: vecchiaia o complotto?
di Nadia Francalacci @ Panorama, 14 febbraio 2013
Ci sono lo Ior, lo scandalo Mps e le norme antiriciclaggio dietro le dimissioni del Papa? Ne parliamo con Ranieri Razzante, esperto di regolamentazione bancaria e antiriciclaggio
Coraggio, umiltà, dignità. Questi gli aggettivi più usati dagli esperti vaticanisti per giustificare le dimissioni del Santo Padre. Anche molti credenti hanno visto nel ritiro del Pontefice un gesto di grande forza e presa di coscienza di un uomo ormai fragile per il trascorrere degli anni.
Ma è stata davvero la vecchiaia la vera causa delle dimissioni del Papa? Il suo ritiro e la sua “reclusione” nel cuore dei giardini vaticani nascondono invece delle pressioni di alcuni alti prelati per cercare di preservare il “tesoro” dello Stato Vaticano? Lo Ior, nonostante l’impegno di Papa Benedetto XVI, è ancora nelle black list. Insomma, è ancora un paradiso fiscale. Ne abbiamo parlato con Ranieri Razzante, docente universitario e esperto di regolamentazione bancaria e antiriciclaggio
Sono in molti a credere che dietro alle dimissioni del Papa non ci sia solo la stanchezza e la vecchiaia ma un complotto o un ricatto. Lei che cosa ne pensa?
Credo solo che il Papa sia stato fiaccato da scandali e problemi burocratico-amministrativi che, da uomo di fede e teologo di fama, non abbia saputo gestire. Forse ha delegato troppo la sua fiducia.
Credo solo che il Papa sia stato fiaccato da scandali e problemi burocratico-amministrativi che, da uomo di fede e teologo di fama, non abbia saputo gestire. Forse ha delegato troppo la sua fiducia.
In questi 8 anni di pontificato di Benedetto XVI si sono susseguiti una serie di scandali e adesso il Vaticano è stato chiamato di nuovo in causa nello scandalo del Monte dei Paschi di Siena con Gotti Tedeschi e lo Ior. Può questa vicenda avere influito sulla decisione del Papa?
Sono un tecnico e, da quanto detto sopra, mi viene solo da aggiungere che il sospetto si possa ingenerare. Abbiamo sentito che la politica deve stare lontana dalle banche. Credo che ciò debba valere anche per lo Ior.
Sono un tecnico e, da quanto detto sopra, mi viene solo da aggiungere che il sospetto si possa ingenerare. Abbiamo sentito che la politica deve stare lontana dalle banche. Credo che ciò debba valere anche per lo Ior.
Gotti Tedeschi è l’uomo voluto dal Papa per fare trasparenza nei conti della banca vaticana… Il suo coinvolgimento nel caso Mps può aver reso vulnerabile e ricattabile il Papa?
Non credo che un Papa sia ricattabile, ma sulle finanze vaticane occorre chiarezza, se non altro per far guadagnare in immagine le strutture interessate.
Nel dicembre 2010 il Papa Benedetto XVI ha introdotto una nuova legge antiriciclaggio entrata in vigore nell’aprile 2011. In che cosa consisteva?
Iniziativa encomiabile che ha dato organicità alla prevenzione del riciclaggio all'interno e all'esterno delle mura vaticane. Un assetto sufficiente, e sempre migliorabile, come ha detto il Moneyval, dei presidi sul contante, sull'adeguata verifica e sulla collaborazione tra autorità. Spero si dia adeguato seguito al motu proprio di Ratzinger.
Iniziativa encomiabile che ha dato organicità alla prevenzione del riciclaggio all'interno e all'esterno delle mura vaticane. Un assetto sufficiente, e sempre migliorabile, come ha detto il Moneyval, dei presidi sul contante, sull'adeguata verifica e sulla collaborazione tra autorità. Spero si dia adeguato seguito al motu proprio di Ratzinger.
Perché il cardinale Tarcisio Bertone ha chiesto a Giuseppe Dalla Torre, presidente del Tribunale Vaticano, dopo alcuni mesi, di stabilire quale fosse la giusta interpretazione da dare alla nuova normativa antiriciclaggio introdotta da Papa?
Credo per evitare conflitti tra poteri dello Stato, data la creazione della Aif, l'autorità contro il riciclaggio (voluta da Papa Ratzinger ndr), che poteva ritenersi giuridicamente interferente con la sovranità dello Ior.
Credo per evitare conflitti tra poteri dello Stato, data la creazione della Aif, l'autorità contro il riciclaggio (voluta da Papa Ratzinger ndr), che poteva ritenersi giuridicamente interferente con la sovranità dello Ior.
Perché il Vaticano sembra non avere alcuna intenzione di mantenere gli impegni assunti in sede europea per aderire agli standard del Comitato per la valutazione di misure contro il riciclaggio di capitali (Moneyval) e sembra non avere alcuna intenzione di permettere alle autorità antiriciclaggio vaticane e anche italiane di guardare nei conti dello Ior?
Per quanto riguarda il Moneyval, il nuovo direttore della Aif, ha promesso l'adeguamento in tempi brevi. Sulla collaborazione con le Autorità italiane bisogna ancora lavorare, nel comune interesse, anche perché ormai tutta l'Europa è arrivata ad un punto di equilibrio in tal senso.
Per quanto riguarda il Moneyval, il nuovo direttore della Aif, ha promesso l'adeguamento in tempi brevi. Sulla collaborazione con le Autorità italiane bisogna ancora lavorare, nel comune interesse, anche perché ormai tutta l'Europa è arrivata ad un punto di equilibrio in tal senso.
-----
Il 19 gennaio 2011 papa Benedetto XVI nomina cardinale Attilio Nicora primo presidente dell'Autorità di Informazione Finanziaria, un organismo di nuova istituzione voluto proprio dal pontefice perché controlli ogni operazione finanziaria vaticana. Ciò avrebbe adeguato anche lo Stato della Città del Vaticano alle nuove norme antiriciclaggio introdotte dall'UE. Ma il 7 luglio 2011,pochi mesi dopo la sua nomina, il Cardinale Nicora si dimette e il Papa è costretto ad accettare le sue dimissioni.
Il 19 gennaio 2011 papa Benedetto XVI nomina cardinale Attilio Nicora primo presidente dell'Autorità di Informazione Finanziaria, un organismo di nuova istituzione voluto proprio dal pontefice perché controlli ogni operazione finanziaria vaticana. Ciò avrebbe adeguato anche lo Stato della Città del Vaticano alle nuove norme antiriciclaggio introdotte dall'UE. Ma il 7 luglio 2011,pochi mesi dopo la sua nomina, il Cardinale Nicora si dimette e il Papa è costretto ad accettare le sue dimissioni.
L’adeguamanto del Vaticano si è arrestato completamente?
Assolutamente no. Il successore chiamato da poco ad occuparsene, al di là del profilo internazionale, sembra deciso a non fermarsi, come colpevolmente si è fatto in passato.
Assolutamente no. Il successore chiamato da poco ad occuparsene, al di là del profilo internazionale, sembra deciso a non fermarsi, come colpevolmente si è fatto in passato.
Marco Lillo: Ior, la guerra del cardinal Bertone per far nominare un suo uomo al vertice @ Il Fatto Quotidiano, 13 febbraio 2013
Ior, la guerra del cardinal Bertone per far nominare un suo uomo al vertice
Il Segretario di Stato del Vaticano vuole escludere il cardinale Attilio Nicora, collaborativo con i pm italiani e severo sulla normativa antiriciclaggio. Il nuovo direttore dell'autorità antiriciclaggio vaticana è invece il bertoniano René Brulhart, uno svizzero che lavorava in un paradiso fiscale
Sarà ricordato per i rotoloni di contanti sotto le tuniche questo Conclave. I cardinali in arrivo da tutto il mondo dovranno portare le mazzette di banconote, se vorranno fare acquisti dentro le mura Leonine, perché i pos dei bancomat della Santa Sede continuano a essere bloccati da gennaio. La Vigilanza della Banca d’Italia negli incontri delle scorse settimane ha posto un aut aut al nuovo direttore dell’Aif, l’autorità antiriciclaggio vaticana, René Brulhart. I soldi non devono più passare per lo Ior ma direttamente dal conto della Deutsche Bank Italia Spa, soggetta alla Vigilanza di Bankitalia. Il Vaticano però ha risposto picche perché non vuole rendere controllabili da Bankitalia i reali intestatari dei flussi e pensa di poter scavalcare l’Italia con una mossa astuta: il bancomat sarà riaperto e appoggiato estero su estero su una banca extracomunitaria non soggetta al controllo di Bankitalia né dell’Europa.
Quella dei rotoloni di contante e dei pos fermi non è l’ombra più lunga dello scandalo Ior che si allunga sulla successione al soglio di Pietro. Nella scelta di Joseph Ratzinger di abbandonare la carica ha giocato un ruolo importante anche la sua sensazione di essere troppo debole per arginare la “mattanza” portata avanti nel settore del controllo delle finanze vaticane dal Segretario di Stato Tarcisio Bertone. Mattanza, più che lotta, è il termine giusto per descrivere l’andazzo degli ultimi mesi confermato ancora il 12 febbraio dall’ultima indiscrezione: il Segretario di Stato ha comunicato informalmente durante i colloqui bilaterali con l’Italia di volere approfittare dei pochi giorni di pieni poteri rimasti per nominare il nuovo consiglio di sovrintendenza e il nuovo presidente dello Ior, la banca del Vaticano.
Bertone presiede la commissione cardinalizia che sovrintende allo Ior della quale fa parte anche il suo rivale, il cardinale Attilio Nicora. Nove mesi dopo la rimozione del presidente Ettore Gotti Tedeschi, più vicino a Nicora e al Papa, Bertone sta per piazzare un suo fedelissimo al suo posto. Il favorito era un ex compagno di studi di Bertone, l’avvocato torinese Carlo Maria Marocco. A dicembre però l’ex notaio, membro dell’attuale Consiglio di sovrintendenza dello Ior, è stato nominato presidente della Cassa di Risparmio di Torino e ora si fa il nome di Pellegrino Capaldo.
L’altra partita fondamentale per Bertone è quella dell’Autorità antiriciclaggio, l’Aif. Dopo essere stato sostituito nel 2011 con il bertoniano monsignor Domenico Calcagno alla guida dell’Apsa, l’amministrazione del patrimonio Santa Sede, Nicora rischia ora di essere rimosso anche dalla presidenza dell’Aif. Bertone potrebbe far valere il doppio incarico di Nicora come ragione di incompatibilità per farlo fuori o dalla presidenza dell’organismo antiriciclaggio Aif o dalla Commissione cardinalizia che controlla lo Ior. Si completerebbe così il disegno che mira a ricondurre sotto il suo controllo l’Aif e lo Ior rimuovendo gli uomini più collaborativi con le autorità italiane.
Gotti Tedeschi ha dovuto lasciare la presidenza dello Ior non certo per il coinvolgimento del banchiere nell’inchiesta della procura di Roma – come erroneamente è stato scritto – ma per una ragione opposta. Insieme al cardinale Attilio Nicora e all’ex direttore generale dell’Aif Francesco De Pasquale, Gotti era il fautore dell’inserimento di una normativa più seria in materia di antiriciclaggio. Lo Ior per decenni si è comportato in Italia come una fiduciaria che scherma i reali proprietari dei fondi, talvolta politici corrotti o criminali comuni dotati della sponda Oltretevere. La Procura di Roma ha indagato nel 2010 il direttore generale dello Ior Paolo Cipriani e Gotti Tedeschi proprio per violazione della normativa formale antiriciclaggio. Ma Gotti, a differenza di Cipriani, si è mostrato collaborativo con la Procura e Bankitalia, un atteggiamento sgradito Oltretevere. Nel dicembre del 2010 Benedetto XVI vara una legislazione antiriciclaggio severa e crea l’Aif, un’autorità antiriciclaggio per dialogare con l’Uif italiana. Comincia lo scambio di informazioni tra Aif e le procure italiane, attraverso l’Uif. Per far capire che fa sul serio, il Vaticano nomina come direttore generale dell’Aif un ex funzionario dell’Uif di Bankitalia, l’avvocato Francesco De Pasquale e come presidente proprio il cardinale Nicora.
A quel punto lo Ior e l’antiriciclaggio diventano il teatro dello scontro tra la fazione dei “vincenti” capeggiata dal segretario di Stato Tarcisio Bertone e i “perdenti” del cardinale Nicora. A gennaio del 2012 Bertone si riprende i poteri ispettivi sullo Ior. L’autorità di Nicora e De Pasquale non può più ficcare il naso nei conti Ior per poi riferire ai pm italiani. A maggio viene messo alla porta il presidente Gotti Tedeschi, favorevole alla normativa più severa. Alla fine del 2012 salta il direttore generale Aif De Pasquale retrocesso a semplice consigliere. Al suo posto arriva René Brulhart, svizzero, ma soprattutto ex capo dell’autorità omologa di un paradiso fiscale come ilLiechtenstein. Non proprio un segnale di severità.
Il cardinale Attilio Nicora sente stringersi il cerchio intorno. Con la scusa della sua doppia carica (controllore, in qualità di presidente Aif e controllato, in qualità di membro della commissione cardinalizia dello Ior) Bertone si accinge a farlo fuori. Un problema che invece non viene rilevato per un altro membro dell’Aif, Giuseppe Dalla Torre, che è presidente del Tribunale del Vaticano. Intanto si avanza un nuovo uomo forte all’Aif: il genero di Antonio Fazio, proprio lui l’ex governatore della Banca d’Italia. Si chiama Tommaso Di Ruzza, è assunto come impiegato, ma è stato subito proposto come vicedirettore. Una nomina saltata proprio per l’opposizione del cardinale Attilio Nicora. Nato nel 1975 ad Aquino e presidente del circolo Tommaso d’Aquino, Di Ruzza è membro del Pontificio consiglio per la giustizia e per la pace.
L’arcivescovo Mamberti e il governatore emerito suocero Antonio Fazio, insieme al vescovo Mario Toso, segretario del Pontificio Consiglio della giustizia e della pace erano presenti alla tre giorni organizzata dal Circolo San Tommaso nel luglio 2012. Non è diventato vicedirettore, ma è stato nominato vicario del direttore. In molti davano per probabile la rimozione di Nicora e l’ascesa del giovane e bravo Di Ruzza al posto di Brulhart nel lungo periodo. Poi sono arrivate le dimissioni del Papa.
mercoledì 13 febbraio 2013
La Chiesa teme la «ferita» al ruolo del Pontefice di Massimo Franchi @ Corriere della Sera, 13 febbraio 2013
La Chiesa teme la «ferita» al ruolo del Pontefice
di Massimo Franchi @ Corriere della Sera
13 Febbraio 2013
Il problema della coabitazione di «due Papi»
UN PORPORATO: IL SUO SUCCESSORE DOVRÀ RIPRENDERE IN MANO LA SITUAZIONE
«E adesso bisogna fermare il contagio...». Il monsignore, uno degli uomini più in vista della Curia, ripercorre le ultime ore vissute dal Vaticano come se avesse subito un lutto non ancora elaborato. E ripete, quasi fra sé: «Queste dimissioni di Benedetto XVI sono un vulnus : una ferita istituzionale, giuridica, di immagine. Sono un disastro». Così, dietro le dichiarazioni di solidarietà e di comprensione nei confronti di Josef Ratzinger, di circostanza o sincere, affiora la paura. È l'orrore del vuoto. Di più: della scomparsa dalla scena di un Pontefice che per anni è stato usato come scudo e schermo da molti di quelli che dovevano proteggerlo e ora temono i contraccolpi della fine di una idea sacrale del papato.
Sono gli stessi che adesso avvertono l'incognita di un successore chiamato a «fare pulizia» in modo radicale; e a ridisegnare i confini e l'identità del Vaticano proprio cominciando a smantellare le incrostazioni più vistose. Le dimissioni vissute come «contagio», dunque. E commentate nelle stanze del potere ecclesiastico come un possibile «virus» che potrebbe mandare in tilt il sistema. «Se passa l'idea dell'efficienza fisica come metro di giudizio per restare o andare via, rischiamo effetti devastanti. C'è solo da sperare che arrivi un nuovo Pontefice in grado di riprendere in mano la situazione, fissare dei confini netti, romani , impedendo una deriva». Lo sconcerto che si legge sulla faccia e nelle parole centellinate dei cardinali più influenti raccontano un potere che vacilla; e un altro che, dopo avere atteso per otto anni la rivincita, comincia a pregustarla.
Eppure, negli schieramenti che si fronteggiano ancora in ordine sparso, non ci sono strategie precise. Si avverte solo il sentore, anzi la convinzione che presto le cose cambieranno radicalmente, e che una intera nomenklatura ecclesiastica sarà messa da parte e rimpiazzata in nome di nuove logiche tutte da scrivere. Ma sono gli effetti di sistema che fanno più paura: e non solo ai tradizionalisti. Un Papa «dimissionabile» è più debole, esposto a pressioni che possono diventare schiaccianti. Il sospetto che la scelta di rottura compiuta da Ratzinger arrivi dopo un lungo rosario di pressioni larvate, continue, pesanti, delle quali i «corvi» vaticani, le convulsioni dello Ior, la «banca del Papa», e il processo al maggiordomo Paolo Gabriele sono stati soltanto una componente, non può essere rimosso. L'interrogativo è che cosa può accadere in futuro, avendo alle spalle il precedente di un Pontefice che si è dimesso. Da questo punto di vista, l'epilogo degli anni ratzingeriani dà un po' i brividi, al di là del coro sulle sue doti di «uomo di fede». La voglia di proiettare immediatamente l'attenzione sul Conclave tradisce la fretta di archiviare una cesura condannata a pesare invece su ognuna delle scelte dei successori.
Il massimo teorico dell'«inattualità virtuosa» della Chiesa che si fa da parte perché ritiene di non avere più forza a sufficienza evoca un peso intollerabile, e replicabile a comando da chi in futuro volesse destabilizzare un papato. Sembra quasi una bestemmia, ma la carica pontificale, con la sua aura di divinità, appare «relativizzata» di colpo, ricondotta ad una dimensione drammaticamente mondana. È come se la secolarizzazione nella versione carrierista avesse sconfitto il «Papa timido» e distaccato dalle cose del mondo; e le nomine controverse decise in questi anni da Josef Ratzinger si ritorcessero contro il capo della Chiesa cattolica. Rispetto a questa realtà, c'è da chiedersi che cosa potrà fare il «successore di Pietro» e di Benedetto XVI per ricostruire la figura papale.
Il vecchio paradigma è franato; il prossimo andrà ricostruito non da zero, ma certamente da un trauma difficile da elaborare e da superare. E questo in una fase in cui la Chiesa cattolica si ripropone di «rievangelizzare» l'Europa, diventata ormai da anni terra di missione; di ricristianizzare l'Occidente contro la doppia influenza del «relativismo morale» e dell'«invasione islamica». Così, nel Papa che si ritrae con un gesto fuori dal comune, schiacciato dall'impossibilità di riformare le sue istituzioni, qualcuno intravede una metafora ulteriore: una tentazione a ritrarsi che travalica i confini vaticani e coinvolge simbolicamente l'Europa e l'Occidente.
Le dimissioni di Benedetto XVI, il «Papa tedesco», finiscono così per apparire quelle di un continente e di una civiltà entrati in crisi profonda; e incapaci di leggere i segni di una realtà che li anticipa, li spiazza, e ne mostra tutti i limiti di analisi e di visione: a livello religioso e civile. I detrattori vedono in tutto questo una fuga dalle responsabilità; gli ammiratori, un gesto eroico, oltre che un bagno di umiltà e di fiducia nel futuro. La sensazione è che per ricostruire, il successore dovrà in primo luogo destrutturare, se non distruggere. In quell'espressione, «fare pulizia», si avverte un'eco minacciosa per quanti nella Roma pontificia hanno sfruttato la debolezza di Ratzinger come «Papa di governo». La minaccia è già stata memorizzata, per preparare la resistenza.
I distinguo appena accennati e le divergenze di interpretazione fra L'Osservatore romano e la sala stampa vaticana sul momento in cui Benedetto XVI avrebbe deciso di lasciare, sono piccoli scricchiolii che preannunciano movimenti ben più traumatici. Scrivere, come ha fatto il quotidiano della Santa Sede, che Benedetto XVI aveva deciso l'abbandono da mesi, significherebbe allontanare i sospetti di dimissioni provocate da qualcosa accaduto di recente, molto di recente, nella cerchia dei collaboratori più stretti. E l'approccio e il ruolo in vista del Conclave dell'attuale segretario di Stato, Tarcisio Bertone, e del predecessore Angelo Sodano, già viene osservato per decifrare le mosse di schieramenti ritenuti avversari. E sullo sfondo rimangono le inchieste giudiziarie che lambiscono istituzioni finanziarie vaticane come lo Ior.
Di fronte a tanta incertezza, l'uscita di scena del Pontefice, annunciata per il 28 febbraio, è un elemento di complicazione, non di chiarimento. «Non possono esserci due Papi in Vaticano: anche se uno di loro è formalmente un ex», si avverte. La considerazione arriva a bassa voce, come un riflesso istintivo e incontenibile. Mostra indirettamente l'enormità di quanto è accaduto due giorni fa. E addita il problema che la Santa Sede si troverà ad affrontare nelle prossime settimane: la convivenza dentro le Sacre Mura fra il successore di Benedetto XVI e lui, il primo Pontefice dimissionario dopo molti secoli. Il simbolismo è troppo potente e ingombrante per pensare che Ratzinger possa diventare invisibile, rinchiudendosi nell'ex convento delle suore di clausura, incastonato in un angolo dei Giardini Vaticani.
Eppure dovrà diventare invisibile: il suo futuro è l'oblìo. La presenza del vecchio e del nuovo Pontefice suscita un tale imbarazzo che qualcuno, come monsignor Rino Fisichella, non esclude novità; e cioè che l'abitazione definitiva di colui che fino al 28 febbraio sarà Benedetto XVI, alla fine sia individuata non dentro ma fuori dai cosiddetti Sacri Palazzi. Il Vaticano, però, è l'unico luogo dove forse si può evitare che venga fotografato un altro uomo «vestito di bianco», gli incontri non graditi, o controllare che anche una sola parola sfugga di bocca a un «ex» Pontefice: sebbene il Papa resterà tale anche dopo le dimissioni. «Ma il popolo cattolico», si spiega, «non può accettare di vederne due». Il paradosso di Josef Ratzinger sarà dunque quello di studiare e meditare, isolandosi in un eremo nel cuore di Roma proprio accanto a quel potere vaticano che ha cercato di scrollarsi di dosso nel modo più clamoroso.
D'ora in poi, seguire i suoi passi significherà cogliere gli ultimi gesti pubblici di una persona speciale che sa di entrare in una zona buia dalla quale non gli sarà permesso di riemergere. Al di là di tutto, la sensazione è che molti, ai vertici della Chiesa cattolica, abbiano una gran voglia di voltare pagina; e che lo sconcerto causato dal gesto di Ratzinger e l'affetto e la stima profonda nei suoi confronti siano bilanciati dal sollievo per essere arrivati all'epilogo di una situazione ritenuta ormai insostenibile. Probabilmente, qualcuno non valuta con sufficiente lucidità che Benedetto XVI non era il problema, ma la spia dei problemi del Vaticano; e che usarlo come capro espiatorio non cancellerà tutte le altre questioni rimaste aperte non soltanto per sue responsabilità. I sedici giorni di interregno che separano dal 28 febbraio, in realtà, segneranno uno spartiacque di secoli. E dimostreranno presto quanto abbia perso vigore non il Papa, ma alcune vecchie logiche. Almeno, Josef Ratzinger ha avuto il coraggio di vederle e rifiutarle.
Eppure, negli schieramenti che si fronteggiano ancora in ordine sparso, non ci sono strategie precise. Si avverte solo il sentore, anzi la convinzione che presto le cose cambieranno radicalmente, e che una intera nomenklatura ecclesiastica sarà messa da parte e rimpiazzata in nome di nuove logiche tutte da scrivere. Ma sono gli effetti di sistema che fanno più paura: e non solo ai tradizionalisti. Un Papa «dimissionabile» è più debole, esposto a pressioni che possono diventare schiaccianti. Il sospetto che la scelta di rottura compiuta da Ratzinger arrivi dopo un lungo rosario di pressioni larvate, continue, pesanti, delle quali i «corvi» vaticani, le convulsioni dello Ior, la «banca del Papa», e il processo al maggiordomo Paolo Gabriele sono stati soltanto una componente, non può essere rimosso. L'interrogativo è che cosa può accadere in futuro, avendo alle spalle il precedente di un Pontefice che si è dimesso. Da questo punto di vista, l'epilogo degli anni ratzingeriani dà un po' i brividi, al di là del coro sulle sue doti di «uomo di fede». La voglia di proiettare immediatamente l'attenzione sul Conclave tradisce la fretta di archiviare una cesura condannata a pesare invece su ognuna delle scelte dei successori.
Il massimo teorico dell'«inattualità virtuosa» della Chiesa che si fa da parte perché ritiene di non avere più forza a sufficienza evoca un peso intollerabile, e replicabile a comando da chi in futuro volesse destabilizzare un papato. Sembra quasi una bestemmia, ma la carica pontificale, con la sua aura di divinità, appare «relativizzata» di colpo, ricondotta ad una dimensione drammaticamente mondana. È come se la secolarizzazione nella versione carrierista avesse sconfitto il «Papa timido» e distaccato dalle cose del mondo; e le nomine controverse decise in questi anni da Josef Ratzinger si ritorcessero contro il capo della Chiesa cattolica. Rispetto a questa realtà, c'è da chiedersi che cosa potrà fare il «successore di Pietro» e di Benedetto XVI per ricostruire la figura papale.
Il vecchio paradigma è franato; il prossimo andrà ricostruito non da zero, ma certamente da un trauma difficile da elaborare e da superare. E questo in una fase in cui la Chiesa cattolica si ripropone di «rievangelizzare» l'Europa, diventata ormai da anni terra di missione; di ricristianizzare l'Occidente contro la doppia influenza del «relativismo morale» e dell'«invasione islamica». Così, nel Papa che si ritrae con un gesto fuori dal comune, schiacciato dall'impossibilità di riformare le sue istituzioni, qualcuno intravede una metafora ulteriore: una tentazione a ritrarsi che travalica i confini vaticani e coinvolge simbolicamente l'Europa e l'Occidente.
Le dimissioni di Benedetto XVI, il «Papa tedesco», finiscono così per apparire quelle di un continente e di una civiltà entrati in crisi profonda; e incapaci di leggere i segni di una realtà che li anticipa, li spiazza, e ne mostra tutti i limiti di analisi e di visione: a livello religioso e civile. I detrattori vedono in tutto questo una fuga dalle responsabilità; gli ammiratori, un gesto eroico, oltre che un bagno di umiltà e di fiducia nel futuro. La sensazione è che per ricostruire, il successore dovrà in primo luogo destrutturare, se non distruggere. In quell'espressione, «fare pulizia», si avverte un'eco minacciosa per quanti nella Roma pontificia hanno sfruttato la debolezza di Ratzinger come «Papa di governo». La minaccia è già stata memorizzata, per preparare la resistenza.
I distinguo appena accennati e le divergenze di interpretazione fra L'Osservatore romano e la sala stampa vaticana sul momento in cui Benedetto XVI avrebbe deciso di lasciare, sono piccoli scricchiolii che preannunciano movimenti ben più traumatici. Scrivere, come ha fatto il quotidiano della Santa Sede, che Benedetto XVI aveva deciso l'abbandono da mesi, significherebbe allontanare i sospetti di dimissioni provocate da qualcosa accaduto di recente, molto di recente, nella cerchia dei collaboratori più stretti. E l'approccio e il ruolo in vista del Conclave dell'attuale segretario di Stato, Tarcisio Bertone, e del predecessore Angelo Sodano, già viene osservato per decifrare le mosse di schieramenti ritenuti avversari. E sullo sfondo rimangono le inchieste giudiziarie che lambiscono istituzioni finanziarie vaticane come lo Ior.
Di fronte a tanta incertezza, l'uscita di scena del Pontefice, annunciata per il 28 febbraio, è un elemento di complicazione, non di chiarimento. «Non possono esserci due Papi in Vaticano: anche se uno di loro è formalmente un ex», si avverte. La considerazione arriva a bassa voce, come un riflesso istintivo e incontenibile. Mostra indirettamente l'enormità di quanto è accaduto due giorni fa. E addita il problema che la Santa Sede si troverà ad affrontare nelle prossime settimane: la convivenza dentro le Sacre Mura fra il successore di Benedetto XVI e lui, il primo Pontefice dimissionario dopo molti secoli. Il simbolismo è troppo potente e ingombrante per pensare che Ratzinger possa diventare invisibile, rinchiudendosi nell'ex convento delle suore di clausura, incastonato in un angolo dei Giardini Vaticani.
Eppure dovrà diventare invisibile: il suo futuro è l'oblìo. La presenza del vecchio e del nuovo Pontefice suscita un tale imbarazzo che qualcuno, come monsignor Rino Fisichella, non esclude novità; e cioè che l'abitazione definitiva di colui che fino al 28 febbraio sarà Benedetto XVI, alla fine sia individuata non dentro ma fuori dai cosiddetti Sacri Palazzi. Il Vaticano, però, è l'unico luogo dove forse si può evitare che venga fotografato un altro uomo «vestito di bianco», gli incontri non graditi, o controllare che anche una sola parola sfugga di bocca a un «ex» Pontefice: sebbene il Papa resterà tale anche dopo le dimissioni. «Ma il popolo cattolico», si spiega, «non può accettare di vederne due». Il paradosso di Josef Ratzinger sarà dunque quello di studiare e meditare, isolandosi in un eremo nel cuore di Roma proprio accanto a quel potere vaticano che ha cercato di scrollarsi di dosso nel modo più clamoroso.
D'ora in poi, seguire i suoi passi significherà cogliere gli ultimi gesti pubblici di una persona speciale che sa di entrare in una zona buia dalla quale non gli sarà permesso di riemergere. Al di là di tutto, la sensazione è che molti, ai vertici della Chiesa cattolica, abbiano una gran voglia di voltare pagina; e che lo sconcerto causato dal gesto di Ratzinger e l'affetto e la stima profonda nei suoi confronti siano bilanciati dal sollievo per essere arrivati all'epilogo di una situazione ritenuta ormai insostenibile. Probabilmente, qualcuno non valuta con sufficiente lucidità che Benedetto XVI non era il problema, ma la spia dei problemi del Vaticano; e che usarlo come capro espiatorio non cancellerà tutte le altre questioni rimaste aperte non soltanto per sue responsabilità. I sedici giorni di interregno che separano dal 28 febbraio, in realtà, segneranno uno spartiacque di secoli. E dimostreranno presto quanto abbia perso vigore non il Papa, ma alcune vecchie logiche. Almeno, Josef Ratzinger ha avuto il coraggio di vederle e rifiutarle.
Accordo con una società svizzera Il Vaticano riattiva i bancomat @ La Stampa (redazionale) 13 febbraio 2013
Accordo con una società svizzera
Il Vaticano riattiva i bancomat
@ La Stampa, 13.02.2013
Il servizio dopo un mese di black out
Torna il bancomat in Vaticano e musei, supermercato, farmacia e attività commerciali varie tirano un sospiro di sollievo. Dopo il «blackout» scattato a inizio gennaio su disposizione della Banca d’Italia per la mancanza di alcune autorizzazioni necessarie, ora il servizio è stato riattivato grazie alla stipula di un nuovo accordo con una società svizzera, Aduno. Ed è proprio nel fatto che Aduno sia svizzera, e quindi fuori dall’Ue, la chiave della soluzione del problema.
Precedentemente, infatti, il servizio per il pagamento tramite pos e bancomat vedeva come operatore Deutsche Bank Italia, soggetto di diritto italiano vigilato da Via Nazionale. Nel corso di una ispezione di vigilanza condotta nel 2010 presso Deutsche Bank Spa, Bankitalia aveva contestato alla banca di prestare servizi di pagamento mediante apparecchi Pos installati nello Stato della Città del Vaticano, extracomunitario, in assenza di autorizzazione. Il Testo Unico Bancario prevede infatti che «le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia». Dopo l’ispezione, Deutsche Bank aveva presentato a sanatoria un’istanza di autorizzazione, che però a dicembre è stata negata per assenza in Vaticano di una legislazione bancaria e finanziaria e di un sistema di vigilanza prudenziale, che si aggiungano a quelli per la lotta al riciclaggio. All’istituto tedesco non é rimasto così che prendere atto dell’esito del procedimento e cessare le attività in Vaticano dal 31 dicembre.
Un problema non secondario per il piccolo stato Oltretevere, sia per le complicazioni per turisti e utenti, sia per le mancate entrate stimate in 30 mila euro al giorno. Per trovare una soluzione, ci sono stati due incontri fra i tecnici di Via Nazionale e l’Aif, l’Autorità di informazione finanziaria vaticana. Nel corso dei colloqui si sarebbero prospettati, per uscire dall’impasse, l’adozione di schemi operativi complessi per adeguarsi agli standard Ue. Schemi che il Vaticano ha deciso di non seguire, preferendo la soluzione della società svizzera, al di fuori dall’Ue e quindi dalla vigilanza Bankitalia nell’ambito dell’eurosistema. Questo non toglie che il lavoro fra Aif e Bankitalia sugli altri temi e più in generale sull’adeguamento della normativa dello Stato della Città del Vaticano non dovrebbe comunque interrompersi. Per risolvere il problema del blocco del Pos si è preferita una strada più veloce. (Davvero ? n.d.r.)
Etichette:
Benedetto XVI,
Finanza,
Money/Moneta,
Vaticano