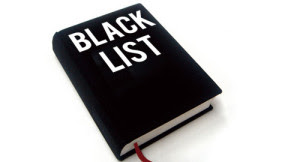INTERVISTA A FRANCO MOTTA SU «ELOGIO DELLE MINORANZE»: Parte III :: Sul divenire maggioranza - tratto da Archeologia delle minoranze: Intervista con Franco Motta - uscita prevista Settembre 2015)
Sul divenire maggioranza
Obsolete Capitalism :: Quali sono le cause per cui, a vostro avviso, una minoranza manca l’appuntamento con la storia, ovvero non accede al proprio destino incompiuto di “divenire maggioranza”?
Franco Motta :: Tutto dipende dal contesto nel quale una minoranza si trova ad agire. Sarebbe azzardato proporre modelli universalmente validi: la sconfitta di una minoranza è inevitabilmente legata alle circostanze che la circondano, agli interessi in gioco, alle forme di comunicazione che adotta, ai rapporti che essa sa attivare con gli attori sociali del momento in cui vive. La nozione gramsciana di egemonia può essere ancora considerata centrale nell’analisi di processi di questo tipo, che sono processi di costruzione di senso, prima ancora che di appropriazione del consenso: e questo pone direttamente al cuore della questione il rapporto fra élite e maggioranze.
Prima di tutto va notato che non necessariamente una minoranza è portatrice di un progetto egemonico o inclusivo. Non mancano gli esempi di minoranze che programmaticamente rifiutano la dimensione del mutamento sociale e praticano piuttosto la separazione dal mondo. La gnosi e il movimento anabattista, ad esempio, hanno scelto questa strada, e non è un caso che in entrambi i casi abbiamo a che fare con impianti filosofici e teologici fortemente dualisti e con la concretizzazione di ideali di distacco dalle pratiche e dai valori sociali.
In secondo luogo occorre tenere presente che un’élite può scegliere deliberatamente di non costruire egemonia per orientarsi invece alla costruzione e al godimento di uno spazio esclusivo fatto di significanti simbolici e di consumi materiali e immateriali. È la nota critica di Christopher Lasch alle élite che hanno “tradito” la loro missione storica, e a mio parere non c’è dubbio che questo tradimento sia una tra le cause dell’afasia della sinistra mondiale negli ultimi trent’anni e del tramonto della narrazione progressista ed egualitarista che si era affermata presso le classi lavoratrici con il socialismo ottocentesco, anche prima di Marx.
Sono convinto, peraltro, che anche nel passato più remoto si possano scorgere fenomeni di questo tipo. Penso ad esempio all’evoluzione disciplinare dell’ordine francescano dopo la morte del fondatore, allorché il radicalismo comunitarista dei cosiddetti «fraticelli» fu marginalizzato e represso dal vertice dell’ordine, in accordo con il papato, per inaugurare la definitiva normalizzazione di quell’istituto all’interno della Chiesa (la capacità di normalizzare e assimilare le soggettività eversive, del resto, è da sempre una specialità del cattolicesimo romano); o penso ancora all’evoluzione conservatrice di Lutero e del ristretto gruppo dirigente del primo movimento evangelico dopo la guerra dei contadini del 1525 e l’allestimento degli apparati ecclesiastici di Stato in Germania, allorché si chiuse l’età eroica della proclamazione del vangelo e si aprì invece una lunga fase di burocratizzazione e di clericalizzazione del ruolo dei pastori.
Infine, e credo di non dire nulla di nuovo con questo, mi sembra di poter affermare che, a parte determinati passaggi storici, gli elementi che giocano in favore della conservazione (elementi intesi tanto in senso soggettivo, cioè come attori sociali, che oggettivo, come condizioni di fondo) abbiano generalmente un compito più semplice degli elementi che giocano in favore del mutamento (che sia un mutamento graduale o rivoluzionario in questo momento non ha gran peso).
Cerco di spiegarmi. Un’élite, o una minoranza nel senso che abbiamo impiegato nel nostro volume, è tale laddove intende innescare e guidare il mutamento, non dove lo subisce. Questa è, come si vede, una definizione funzionale, non assiologica. Tale mutamento, poi, a nostro parere può essere di segno progressivo o conservatore, dato che presupponiamo che anche la conservazione dell’ordine richieda uno sforzo continuo di controllo della complessità sociale con le sue “peristalsi” e i suoi incessanti processi di aggregazione e disgregazione; è per questo che, nell’introduzione al volume, abbiamo esposto la nozione (molto criticata da Corrado Ocone nella sua recensione sul «Corriere della sera», ma a mio parere non veramente discussa) di ‘élite progressiste’ e di ‘élite conservatrici’, leggendo la storia dell’Italia moderna alla luce della ripetuta vittoria di queste ultime.
Si dirà: questa è una banale dicotomia tra forze ‘buone’ e ‘cattive’, di sinistra e di destra, che non prende in considerazione il fatto che storicamente molti fra i soggetti che possono essere variamente identificati con la conservazione, la reazione, la “destra” (perdonami quest’accezione quasi metafisica del concetto) abbiano determinato profondi cambiamenti sociali. Per rispondere a questo mi limito a osservare che il mutamento può essere di segno doppio, ossia indirizzato a valori di progresso oppure a valori di conservazione, dove per valori di progresso intendo semplicemente quelli che appartengono all’eredità dell’Illuminismo, a quella del marxismo e ad altre eredità che risalgono più indietro nel passato e si trovano variamente intrecciate nel tessuto culturale della sinistra (l’umanesimo ne è un esempio). Da questo punto di vista rifiuto – in prospettiva etica, naturalmente, non epistemologica – le tesi differenzialiste e relativiste e credo nell’imperativo morale di ritenere “assoluti” alcuni valori, anche se sappiamo benissimo che sono un prodotto della storia: la laicità, l’autonomia dell’individuo, la lotta alla povertà e all’ignoranza, la parità di genere etc.
Ciò detto, prendiamo in considerazione alcuni esempi. Il primo è il fascismo, o meglio i fascismi. Certo il fascismo, nel caso italiano, è stato una forza rivoluzionaria: ha abbattuto la classe dirigente del vecchio Stato liberale, ha creato l’industria di Stato, ha dato un grande impulso all’ammodernamento infrastrutturale etc. Ma se analizziamo gli attori sociali che hanno beneficiato della dittatura scopriamo che essi sono esattamente gli stessi che esercitavano il privilegio nel secolo precedente: la borghesia industriale, quella rurale del Nord, l’aristocrazia agraria del Mezzogiorno, gli ordini professionali, l’alto clero etc. Quanto agli assi portanti della cultura fascista – l’esaltazione della violenza, lo schiacciamento della donna sul ruolo materno, l’enfasi posta sulle differenze, il culto del capo e il primato della gerarchia, la marginalizzazione delle diversità etc. – avrei sinceramente difficoltà a indicarne uno solo che non possa essere interpretato come prosecuzione nell’età industriale dei valori che erano propri delle minoranze aristocratiche ed ecclesiastiche dell’Antico regime.
Lo stesso biologismo razzista, che forse è il tratto più innovatore dei fascismi degli anni Trenta, è l’avatar scientistico del principio della insuperabilità delle differenze etniche che troviamo, ad esempio, negli statuti di limpieza de sangre della Spagna quattrocentesca o nelle tesi aristoteliche sulla schiavitù naturale dei neri e degli indios che sostenevano gli interessi degli encomenderos spagnoli e dei commercianti di schiavi inglesi e francesi. Letta in questa prospettiva, l’idea di “mutamento conservatore” appare forse meno ossimorica di quanto sembri. Naturalmente il caso del fascismo ci mostra anche qualcos’altro, e cioè che non possiamo ridurre alla semplice coppia conservazione/progresso il ruolo storico delle minoranze. Prendo altri due esempi.
I gesuiti, la grande élite intellettuale della Chiesa della Controriforma, furono innovatori straordinari nei campi della pedagogia, della comunicazione, della lotta politica, della pratica religiosa (penso all’impatto straordinario che ebbe nel XVI secolo la preghiera mentale come veicolo di conversione); ma difficilmente si può dubitare del fatto che il loro obiettivo, sullo scacchiere europeo, fosse quello di difendere e rifondare, anche su basi nuove, alcuni princìpi di fondo che appartenevano alla tradizione della Chiesa romana dai tempi di Gregorio VII: il primato papale, la Chiesa gerarchica, la rigida separazione fra clero e laicato, la funzione direttiva del magistero romano rispetto alle autorità civili. Se passiamo ai territori extraeuropei scopriamo invece che i gesuiti vi svolsero un ruolo assai più duttile. In Cina e in India, seppure per motivi apologetici, seppero valorizzare la diversità delle culture grazie alla teoria e alla pratica del cosiddetto «accomodamento», e di certo i conservatori non furono loro, bensì i loro avversari domenicani nelle querelle dei riti cinesi e malabarici; allo stesso modo le celebri reducciones del Paraguay furono uno straordinario esperimento di costruzione di una possibile ‘alternativa coloniale’ nella quale gli indios erano affrancati dall’assoggettamento brutale imposto dagli encomenderos. Così come i giacobini del Comitato di salute pubblica del 1793-94 furono da un lato i primi fautori in assoluto dei diritti sociali con il loro attacco all’intangibilità della proprietà privata, ma al tempo stesso furono profondamente conservatori nella loro fedeltà al mito della piccola proprietà quale cittadella delle virtù civiche e repubblicane.
A valle di queste considerazioni credo possa risultare più fondata la mia tesi secondo la quale molti fallimenti delle élite progressiste possono essere imputati alla maggiore forza storica oggettiva dei loro avversari, cioè delle élite conservatrici. Ogni società complessa – e uso questo aggettivo in un’accezione larghissima che include tutte le società con un certo grado di stratificazione sociale e di specializzazione delle funzioni – ha la tendenza a disporsi in strutture piramidali, nelle quali la ricchezza, il potere e la forza di coercizione sono monopolio di un vertice più o meno ristretto di soggetti individuali e collettivi. Ne consegue che le forze che difendono la stabilità e la conservazione del sistema possono contare su risorse generalmente maggiori di quelle delle forze che invece operano per un’alterazione del sistema.
Un caso classico è quello della presa del potere da parte di Mussolini: certo l’élite socialista ebbe più d’una responsabilità nella propria sconfitta (l’incapacità di capire davvero la novità rappresentata dalla violenza fascista, il tentativo di difendere le posizioni acquisite attraverso il negoziato con il ceto politico liberale, le divisioni interne etc.), ma non si può dimenticare che, a differenza che in Russia, in Italia l’apparato dello Stato uscì dalla guerra perfettamente integro, e che esso favorì, o addirittura appoggiò l’azione delle squadre fasciste allorché smantellarono le organizzazioni operaie e contadine, le cooperative e le amministrazioni locali socialiste.
Questo a mio parere non vale soltanto per le opzioni rivoluzionarie, come quella che fu perseguita dalle élite dirigenti della classe operaia italiana, tedesca o ungherese fra il 1918 e il 1921, ma anche per le opzioni di riforma e di mutamento graduale. Gli illuministi vinsero la loro battaglia culturale – ad esempio sul tema della tolleranza religiosa – perché nella seconda metà del XVIII secolo la presa delle istituzioni ecclesiastiche sulla società e sui ceti dirigenti francesi era in crisi conclamata, mentre meno di un secolo prima l’espulsione dei calvinisti dalla Francia, decretata da Luigi XIV nel 1685, fu accolta dal paese come un fatto normale.
Con questo, la responsabilità diretta delle élite nei loro fallimenti non deve essere posta in secondo piano, e spero che l’Elogio delle minoranze sia riuscito a chiarire come la nostra posizione sia estranea a quello «sconfittismo», e cioè alla ricerca della propria identità nell’insuccesso che preserva l’integrità della virtù, che è costitutivo della tradizione della sinistra italiana. ( segue QUI )
Franco Motta è ricercatore in Storia moderna presso l'Università di Torino. Tra i suoi interessi di studio, le strategie politiche e culturali della Chiesa cattolica tra XVI e XVIII secolo. Ha curato l'edizione della 'Lettera a Cristina di Lorena di Galileo Galilei' (Marietti 2000) ed è autore di una biografia del cardinale Roberto Bellarmino (Bellarmino. Una teologia politica della Controriforma, Morcelliana 2005). Con Massimiliano Panarari ha pubblicato nel 2012, presso le edizioni Marsilio, il pamphlet storico-politico 'Elogio delle minoranze. Le occasioni mancate dell'Italia'. Ultima pubblicazione nel 2014, tramite le Edizioni Il Sole 24 ore: 'Bellarmino. Teologia e potere nella Controriforma'.
---------------------
Elogio delle minoranze
Le occasioni mancate dell'Italia

Cosa accomuna gli eretici italiani del Cinquecento e i social-riformisti dell'Italia primo-novecentesca, i galileisti del Seicento e gli igienisti dell'Ottocento, i protagonisti del Triennio giacobino e la famiglia allargata dei liberali di sinistra e progressisti? Innanzitutto l'atteggiamento mentale critico, consapevole, ma sempre distinto dal pragmatismo e dall'antidogmatismo. Infine un amaro destino: duramente sconfitti, costretti ad assistere in vita alla dissoluzione dei loro progetti, sono stati anche oggetto di dimenticanza o di damnatio memoriae. Massimiliano Panarari e Franco Motta ripercorrono la storia del nostro paese rileggendola attraverso le esperienze di quelle "grandi" minoranze virtuose, che hanno combattuto battaglie di stampo riformatore e per il cambiamento delle condizioni di vita. Un filo rosso attraversa il libro alla ricerca delle energie fondative di quella che avrebbe potuto essere un'altra Italia, i cui esponenti si rivelano oggi più vicini ai modelli sociali e culturali che risultarono vincenti in buona parte dell'Occidente sviluppato.