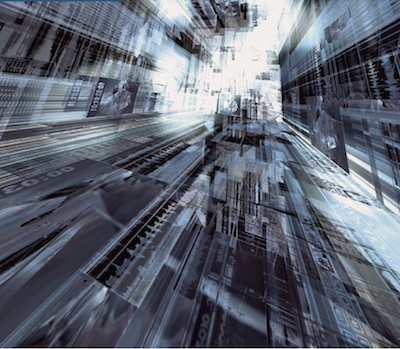Per una teoria delle minoranze
di Obsolete Capitalism
Il sapere primo del pensiero classico ( Parte III )
Soffermiamoci ancora su quel 'magico' momento in cui Cartesio universalizza l'atto del confronto, rendendolo, come afferma Michel Foucault (Le parole e le cose, 1966), nella "sua forma più pura". Ogni conoscenza è "ottenuta attraverso il confronto di due o più cose fra di loro" (Cartesio, Regulae, 1628). Con quali atti collettivi comparativi si apprende la volontà del popolo sovrano se non attraverso l'esercizio democratico e il rito partecipativo della competizione elettorale tra eguali e liberi che assegna una maggioranza, più o meno qualificata, in grado di tradurre in azione politica le scelte della totalità approssimata? Si esperisce e si conosce la volontà della maggioranza attraverso il confronto democratico. E' nel confronto tra le proposte politiche che si dispiegano identità e differenze, misura e ordine. Il metodo razionale matematico-scientifico cartesiano permette di abbandonare, anche per ricerche circostanziate come quelle di Motta e Panarari che qui analizziamo, le quattro similitudini che hanno svolto una parte "costruttiva nel sapere della cultura occidentale" fino alla fine del XVI secolo: vicinanza, emulazione, analogia e simpatia. Con Cartesio hanno termine le relazioni esoteriche, i concatenamenti instabili, le similitudini intricate, le parentele oscure mentre il confronto tra gli oggetti, anche politici, ne guadagna in nitore, trasparenza ed esattezza numerica. Resta in campo solo il confronto tra confronti: quello tra ordine e misura. Se nell'età classica della civiltà greca, e dunque all'apogeo della città-stato - laboratorio storico della grammatica politica contemporanea - il confronto tra misura e ordine veniva risolto, come ultima ratio, dalla stasiologia - la teoria della guerra civile (Agamben, Stasis, 2015) che segna l'integrazione definitiva della famiglia nella mobilitazione partitica e nell'ordine politico della città ed esautora di fatto la misura rendendo indecidibile non solo il fratello e il nemico, ma pure il maggiore e il minore - allora, nell'età classica della civiltà europea, all'apogeo delle nazioni-stato, il confronto tra misura e ordine viene, nel caso della prima, ricondotta "alle relazioni aritmetiche dell'uguaglianza e della disuguaglianza", mentre nel secondo caso viene considerato come oggetto di studio, prima il tutto e poi successivamente le parti. La misura analizza in unità, l'ordine fissa degli elementi. L'obiettivo del confronto consiste appunto nel ricondurre ogni misura a un ordine seriale, dal più semplice al più complesso. La civiltà occidentale, sublimando psicologicamente la teoria della guerra civile, assegna al dispositivo misura/ordine lo scopo principale di ordinamento del mondo e da ciò ne discende, nel nostro assetto politico-istituzionale, il marcare le misure attraverso le competizioni elettorali tra partiti e l'ordinare i poteri attraverso le separazioni equilibrate di organi legislativi, esecutivi e giudiziari. Così uno dei cardini fondamentali del pensiero politico della modernità - la democrazia rappresentativa e la conseguente 'dittatura quantitativa' realizzata attraverso la sovranità parlamentare - è stato plasmato dall'egemonizzante filosofia razionale del XVII secolo. La mathesis assurge, sempre nell'analisi strutturalista di Foucault, a scienza universale della misura e dell'ordine. Chi potrà mai scalfire politicamente e filosoficamente, ai giorni nostri - il secolo di Google - la potenza astratta e la forza materiale della mathesis, dopo oltre 200 anni di dominio ininterrotto?
( segue QUI )
(tratto dall'e.book Archeologia delle minoranze. Intervista con Franco Motta su "Elogio delle minoranze" - in uscita a Settembre 2015)
picblog: Ryoichi Kurokawa - Syn_2014 (fragment)